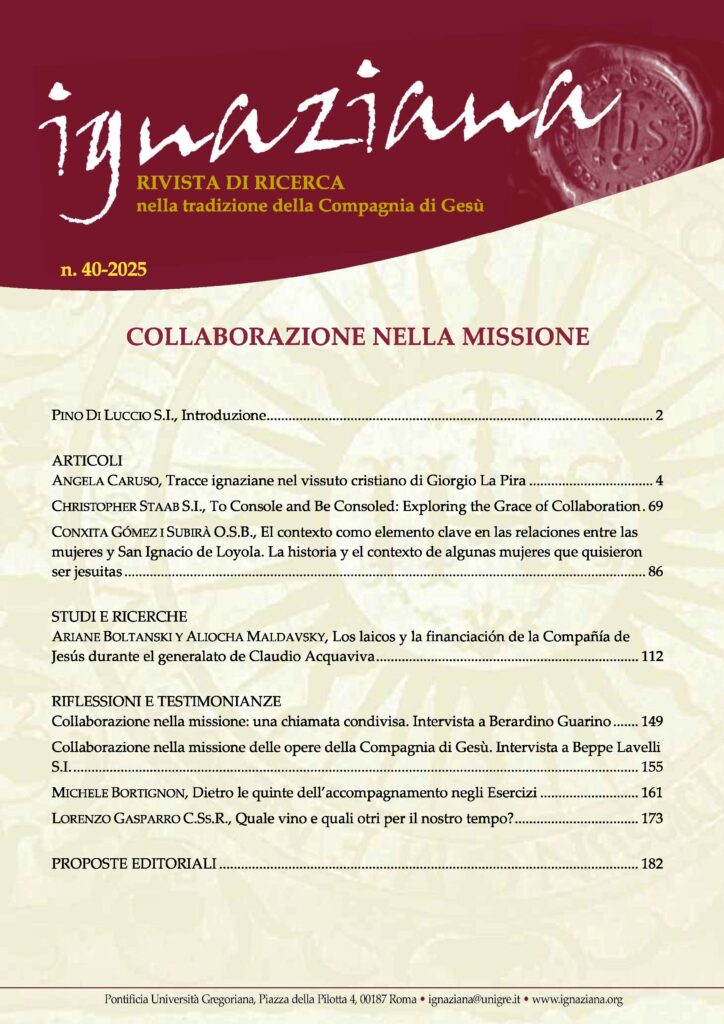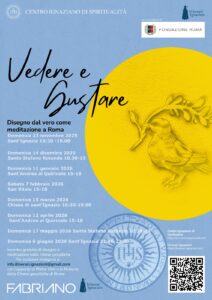Simposio, Monaco di Baviera, San Martino
Peter Musto, “Neanche io ti condanno!” (Gv 8,11)
Perdonare e chiedere perdono
Un’arte che impariamo nel corso della nostra vita
“Mi dispiace!”. “Scusami!”. “Non arrabbiarti!”.
Pronunciamo spesso queste parole. Le usiamo per risolvere in modo rapido ed educato un inconveniente momentaneo che è sorto nella nostra vita comune. Sono frasi che sembrano semplicemente mostrare la nostra gentilezza, ma, mentre le pronunciamo, già sospettiamo o percepiamo che abbiamo, anche involontariamente, reso più difficile la vita ad un altro.
Fin dall’infanzia abbiamo sentito i nostri genitori dire: “Bene, chiedi perdono!”. Spesso abbiamo eseguito questo richiamo con obbedienza. I nostri genitori hanno fatto bene a inculcarci dei rituali che ci permettono di esprimere la nostra intenzione di voler riparare, nella vita, una relazione disfunzionale.
Da adulti, le nostre esperienze ci fanno capire che noi, in qualità di persone interessate, dobbiamo prendere posizione quando abbiamo ferito qualcuno o quando noi stessi siamo stati feriti: in queste situazioni, si tratta plasmare una relazione con un’altra persona ed è in gioco il futuro di quella relazione.
Spesso ci rendiamo conto che le parole che usiamo per chiedere perdono o per esprimere la nostra intenzione di perdonare non sono sufficienti a far progredire la relazione, in modo positivo.
Perdonare e chiedere perdono ci mettono alla prova e si ripetono costantemente nella convivenza umana. Ho ferito qualcuno e cerco la mia responsabilità in quello che è accaduto, in modo che la relazione possa tornare in equilibrio, in modo soddisfacente. Oppure vengo ferito e mi tormento per i sentimenti e il dolore che ho provato e per la mia difficoltà a perdonare. Passiamo una vita a cercare di capire come chiedere perdono, affinché la relazione possa continuare, e come perdonare per liberarci dai vincoli del risentimento, della rabbia e della paura. In modo da poter guardare di nuovo con favore l’altro e noi stessi. In modo da poter amare di nuovo.
Finché ci occupiamo delle nostre accuse
non sentiamo il dolore della ferita
Nelle situazioni di perdono e di richiesta di perdono, ci sono sempre risentimento, rabbia, collera e sentimenti di vendetta. Ci troviamo ad affrontare il dolore dell’altra persona o il nostro. Siamo influenzati da ciò che è accaduto. Siamo feriti, offesi. La nostra anima si chiude per difendersi. I sentimenti negativi ci fanno vedere in modo distorto l’altra persona e la nostra relazione. Rimaniamo bloccati in essi. La ferita ci rende ciechi e vediamo solo il nostro punto di vista. Siamo incapaci di empatia. È così che funzioniamo.
Giudichiamo e accusiamo l’altro. Inevitabilmente, condanniamo l’altro. È qui che ci perdiamo. In questo stato d’animo, sotto accusa, non riusciamo nemmeno ad ammettere ciò di cui siamo colpevoli. La paura ci trattiene dal confessare, per non essere lapidati. Essere in grado di guardare e giudicare più a fondo una determinata situazione è possibile, solo se smettiamo di cercare il colpevole. Solo allora, potremo scoprire la natura diversa di ciò che è accaduto e le motivazioni nascoste e più sottili che si celano sullo sfondo. Se guardiamo le cause e i contesti dell’incidente non solo nello specchio dei nostri sentimenti, ma ci chiediamo anche cosa sta mettendo a rischio la relazione, allora siamo meno prevenuti, non siamo sotto pressione per difenderci e possiamo guardare a noi stessi, all’altro e alla relazione con più facilità. Se non giudichiamo o accusiamo nessuno, possiamo capire più facilmente cosa è successo. Se prendiamo tempo, sopportiamo la tensione, non iniziamo subito a parlare e restiamo tranquilli dentro di noi, allora non saremo tranquilli nel nostro giudizio, che credevamo già certo. Questo vale anche per l’autoaccusa. Se rimaniamo in silenzio, il vero dolore si rivela nel conflitto.
Nel silenzio della meditazione, della preghiera contemplativa, spesso intraprendiamo un dialogo con il nostro partner in conflitto, anche contro la nostra volontà. Un dialogo in cui l’altra persona è assente. Speriamo e aspettiamo che l’altra persona riconosca il nostro dolore, che sia d’accordo con noi. Vogliamo sentirci dire che ci capisce. Questo dialogo continua all’infinito. Ci risparmia il dolore. Finché la conversazione è unilaterale, sentiamo solo la spiacevole pressione che questo dialogo interiore esercita su di noi. Ma copre i sentimenti negativi più profondi e nascosti dentro di noi. Siamo riluttanti nell’ammettere l’angoscia del conflitto. Nel dialogo interiore, teniamo lontani i nostri sentimenti e nascondiamo il dolore interiore. Ma quando diventiamo consapevoli del risentimento, della rabbia, dell’ansia, della delusione di non essere compresi, la pressione del dialogo interiore scompare. Si ferma.
Nella preghiera contemplativa, ci esercitiamo a permettere tutto. Guardare con coraggio. Rimanere dove fa male dentro di noi. E impariamo a non giudicare.
Il letterato e filosofo francese, divenuto cieco durante la sua infanzia, Jacques Lusseyran dice: amare è vedere. L’odio ci rende ciechi. L’attenzione è un modo di toccare.
Molte cose appaiono diverse quando ci soffermiamo nel silenzio
“Nessuno ti ha condannata?” (Gv 8,10)
Gli scribi e i farisei portano l’adultera da Gesù. La accusano, la giudicano, la disprezzano. Vogliono sistemare la questione, condannandola. E si aspettano anche che Gesù la condanni. Ma lui si comporta con la donna, in modo molto diverso da come ci si aspetta. Prende tempo, crea pace e tranquillità nella folla agitata, non cerca qualcuno da incolpare, non giudica. Finché è chino a scrivere sulla sabbia, attira l’attenzione degli accusatori altrove, lontano dall’imputata. Così facendo, blocca l’accusa sul nascere. Gli accusati si sentono improvvisamente a disagio. Forse non sopportano il silenzio. Finché accusano, sono al sicuro nel loro giudizio. Ma durante il grande silenzio, potrebbero ricordare momenti della loro vita che ora li rendono insicuri nel loro modo di agire. Non se lo aspettavano.
Nel silenzio vedono sé stessi in modo diverso. Anche la donna viene percepita in modo diverso. Attraverso il silenzio, Gesù permette anche alla donna di riprendersi. “Neanche io ti condanno!”.
Si tratta di rinnovare una relazione in pericolo
Solo una persona con cui abbiamo una relazione può farci del male. Il processo di perdono avviene proprio grazie a questa relazione. Il rapporto è messo a rischio dalla ferita. Quando chiediamo perdono o vogliamo perdonare noi stessi, la nostra intenzione è quella di riparare o salvare la rottura che si è verificata nella relazione. In modo che possa tornare a vivere e approfondirsi. Lo sperimentiamo con Dio, tra di noi e con noi stessi.
Non è indifferente
come chiediamo perdono
Per chiedere perdono dobbiamo prima riconoscere che siamo colpevoli verso chi ci perdona. “Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono” (Mt 5,23-24).
Quando chiediamo perdono molto velocemente, il problema riguarda noi e non l’altra persona. Quando siamo veloci nel “perdonare”, vogliamo far finta che non sia successo nulla.
Giacobbe ha dovuto lottare tutta la notte con il suo lato oscuro sconosciuto, prima di poter affrontare suo fratello, riconciliato con sé stesso. Così non c’è stata nessuna lotta tra i due, anche se si sono separati di nuovo dopo il loro incontro pacifico (cf. Giacobbe ed Esaù: Gen 32).
Non è uguale come noi ci perdoniamo
Indipendentemente dal modo in cui reagiamo, il fatto che ci siamo offesi avrà un impatto sulla relazione. Offendendoci, segnaliamo all’altra persona: mi hai ferito, mi hai fatto qualcosa di brutto. L’altra persona è inevitabilmente ferita da questo feedback. Nella stragrande maggioranza dei casi, non ce ne rendiamo nemmeno conto quando sentiamo il nostro stesso dolore. In una situazione come questa, non siamo in grado di percepire la situazione in cui si trova l’altra persona. Si trova a dover affrontare il fatto di aver ferito qualcuno, intenzionalmente o meno. Questa consapevolezza risveglia sensi di colpa, ci si sente impotenti e si può provare risentimento. L’aggressore si sente improvvisamente vittima.
Se ci sentiamo offesi e non ci rendiamo conto che anche l’altra persona è stata colpita e soffre per quanto accaduto, la relazione non può essere riparata. Si indebolisce. I contatti diventano sempre più rari e la continuazione della relazione viene messa a rischio. Tuttavia, la relazione potrebbe anche rafforzarsi se entrambe le persone hanno l’intenzione di percepire lo sgomento dell’altro.
È utile prendersi il tempo necessario per percepire meglio ciò che accade dentro di noi e ciò che potrebbe accadere nell’altra persona. Con il tempo, possiamo capirci a vicenda se non ci lecchiamo le ferite.
Chi perdona è in grado di riconoscere che l’altra persona, che ha causato il dolore, non è solo un colpevole. Non è solo la causa della situazione che si è creata, ma anche una vittima. Chi perdona capisce che anche l’altra persona ha bisogno di conforto.
Quando entrambe le persone vedono chiaramente dentro di sé, è più facile trovare un modo per continuare a lavorare sulla loro relazione.
Cosa deve essere messo in ordine in noi,
perchè la riconciliazione abbia successo
Riconciliare, perdonare e scusarsi sono termini con lo stesso contenuto. Vedo una differenza nel fatto che la riconciliazione è un processo interiore. Affrontiamo il nostro dolore, il nostro odio, i nostri sentimenti di vendetta e il fatto che ci vergogniamo di farlo. Complesse correnti di emozioni ci scuotono interiormente, come un torrente impetuoso che spazza via tutto quando la neve si scioglie.
Quando ci riconciliamo, l’anima si calma di nuovo. Spesso indipendentemente dalla persona che ci ha ferito.
Per riparare una relazione,
sono necessarie entrambe le persone coinvolte
Durante il processo di riconciliazione, la nostra attenzione è in parte concentrata su noi stessi, in parte sulla persona che ci ha offeso o sulla persona che abbiamo offeso.
È possibile decidere di affrontare la questione da soli e non cercare il dialogo con l’altra persona. A volte l’altra persona rifiuta di entrare in dialogo con noi. Anche se in fondo alla nostra anima, rimaniamo legati o invischiati. Non riusciamo a separarci.
In molti casi, è inevitabile confrontarsi con le nostre paure, che determinano le nostre reazioni. Questo è l’unico modo per ristabilire una relazione soddisfacente. Se ci rendiamo conto di essere determinati dalle nostre paure, è bene prestare attenzione a ciò di cui abbiamo effettivamente paura, quando ci offendiamo o quando un’altra persona si sente offesa da noi. Abbiamo paura di perdere l’altra persona? Di essere messi in imbarazzo? Abbiamo paura di vergognarci di essere colpevoli? Di non essere riusciti ad essere buoni, amati e accettati? Abbiamo paura che la nostra immagine di noi stessi venga danneggiata? Di non essere comprensivi, pazienti e generosi come vorremmo?
Le nostre paure nascoste, il dolore delle nostre ferite aumentano la possibilità delle perdite che potremmo subire. Nascondono i vantaggi della relazione. Nascondono facilmente ai nostri occhi il fatto che ripristinare una buona relazione può essere molto importante per l’altra persona. E quando reagiamo, a causa delle nostre paure, rafforziamo anche la paura nell’altra persona.
Quando scopriamo che la paura determina il nostro modo di agire e abbiamo riconosciuto ciò di cui abbiamo paura, non ne siamo automaticamente liberi. A volte, la paura ci domina così fortemente che non riusciamo a controllarla. In questi casi, non abbiamo altra scelta che riconoscere i nostri limiti. Questo ci aiuta.
A volte, invece, siamo in grado di decidere in modo tale che la paura non guidi le nostre azioni. Questa decisione non deriva da una visione razionale o da una determinazione, ma piuttosto da una fiducia di base. Dalla fiducia nella vita, in noi stessi, negli altri. Questa fiducia non può essere forzata, ma può essere coltivata ed esercitata. Possiamo risvegliarla in noi stessi.
Per far ripartire la relazione, possiamo anche provare con le parole. Basta prestare sempre attenzione a come vengono recepite dall’altra persona. Dall’effetto che le nostre parole hanno sull’altra persona, possiamo leggere le motivazioni con cui le abbiamo pronunciate. Non abbiamo mai una visione chiara delle nostre motivazioni. Può accadere che le parole, che esprimono la volontà di riconciliarsi, vengano usate come armi contro l’altra persona.
Se tiriamo fuori tutto, se vogliamo risolvere tutto in una volta, questo potrebbe solo danneggiare la relazione. Non tutto può essere chiarito, non tutto può essere discusso. Molte cose possono essere sistemate con un gesto, con un sorriso, con la comprensione della buona volontà. Un gesto del genere può eliminare gran parte dell’asprezza del conflitto. Cercare di risolvere tutto può solo portare a ferire nuovamente l’altra persona. Possiamo contare sul fatto che nella relazione non è solo efficace il chiarimento razionale.
Vediamo la stessa cosa nel Vangelo, quando Giuseppe è incerto se prendere con sé Maria. Alla fine, si affida al suo sogno e si riconcilia con Maria senza averle parlato (Mt 1, 18-24).
Non c’è pace senza perdono
La Scrittura ci incoraggia ripetutamente a perdonarci a vicenda. Anche se non sempre ci riusciamo.
In realtà abbiamo bisogno di riconciliarci. Non ci fa bene covare rabbia, odio, indifferenza ed emarginazione nel nostro cuore, se mettiamo da parte qualcun’altro per sempre. O addirittura disprezziamo noi stessi. È doloroso non essere in grado di amare, di essere benevoli. L’energia vitale non fluisce facilmente quando è bloccata dal rifiuto di qualcuno. La gioia di vivere può facilmente svanire. Uno stato d’animo allegro e pieno di vita viene schiacciato quando serbiamo rancore verso qualcuno. Il perdono è un dono. La leggerezza nella vita ha il sopravvento. Possiamo amare e gioire di nuovo.
Non ho mai avuto paura
che Dio potesse essere arrabbiato con me
I testi liturgici ci ripetono che non dobbiamo chiedere perdono solo agli altri, ma anche a Dio. Ogni volta che ci sentiamo in colpa nei Suoi confronti.
Guardiamo a Dio come se fosse un altro essere umano. Gli chiediamo perdono. Come se Dio dovesse perdonarci per qualcosa. Non è Dio che ha bisogno delle nostre scuse. Dio non può essere offeso da noi. Dio non è offeso, non è arrabbiato. Dio non porta rancore. L’Antico Testamento parla dell’ira di Dio, nei confronti delle persone, proprio come noi esseri umani possiamo essere arrabbiati gli uni con gli altri.
Non riesco a vedere Dio come un essere umano. Tutto viene da Lui, quindi anche il male – ciò che noi vediamo come male – deve avere qualcosa a che fare con Dio. Nel mondo, così come in me stesso e nei miei simili. Tutto ciò che esiste, esiste solo finché Dio lo tiene in esistenza. Se Dio rifiuta qualcosa, essa non esiste più (Sap 11,26).
In gioventù, mi è stato detto che tutto il male deriva dal libero arbitrio umano. Se Dio ci ha creato in modo tale che possiamo fare il male, allora Dio ha voluto almeno la possibilità del male. Dio ha previsto il male nella sua opera e lo usa sempre per i suoi scopi.
Non ho mai avuto la sensazione che Dio potesse essere arrabbiato con me. Anche se non ho sempre fatto ciò che ritenevo giusto e opportuno.
Secondo la genealogia di Gesù (cf. Mt 1,7), il Salvatore proviene anche da Davide, noto per il suo grande peccato, la sua relazione con Betsabea, moglie di Uria morto assassinato [per mano di Davide] (cf. 2Sam 11).
Dio consola
Quando chiediamo a Dio il perdono, abbiamo bisogno della sua consolazione. Il vero pentimento è il dolore per la nostra incapacità di fare il bene e, allo stesso tempo, la consolazione di non essere rifiutati. Dio ci toglie la vergogna. Dio ci conforta.