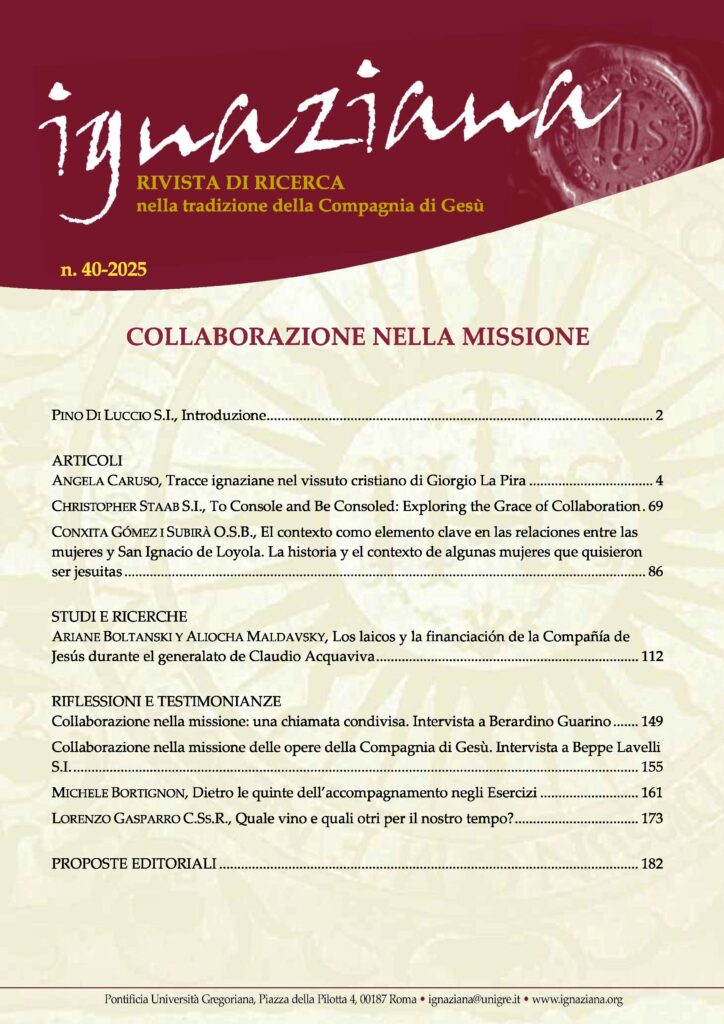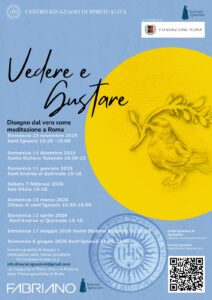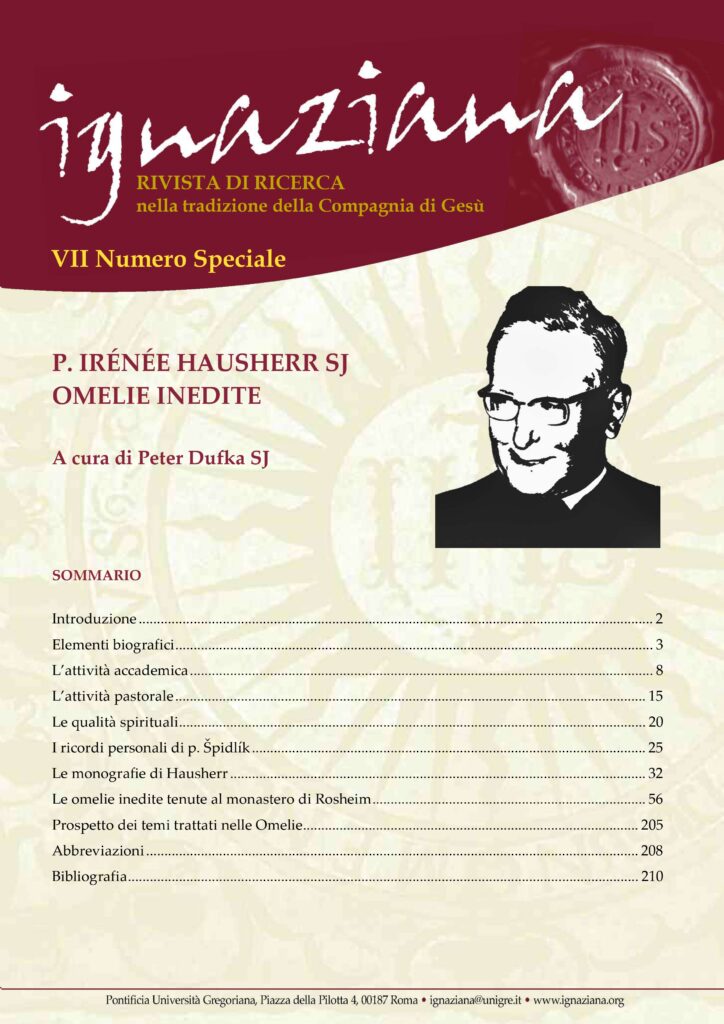di Paul Oberholzer S.I.
Abstract
L’articolo analizza il significato storico, politico e spirituale del concetto di “Gerusalemme” nella Spagna tardomedievale e nei primi decenni dell’età moderna. Attraverso un’ampia indagine storica, l’autore mostra come l’ideale di Gerusalemme abbia influenzato la formazione dell’identità spagnola, intrecciandosi con la Riconquista, le crociate mancate, le profezie escatologiche e l’espansione oltremare. Viene ricostruita la visione messianica di monarchia universale, alimentata da figure come Arnaldo de Villanueva e culminata nella politica dei Re Cattolici e di Carlo V. L’articolo evidenzia come questo immaginario abbia influenzato anche Ignazio di Loyola, giovane paggio alla corte spagnola, e il suo progetto spirituale e missionario.
The article explores the historical and symbolic significance of Jerusalem in the political and religious culture of late medieval Spain. Through extensive historical research, the author shows how the idea of Jerusalem was reinterpreted through national, messianic, and imperial lenses, shaping the Reconquista, the policies of the Catholic Monarchs, overseas expansion, and Spanish identity. Figures like Arnaldo de Villanueva and Columbus helped construct a prophetic and geopolitical vision of Jerusalem as the ultimate goal of a universal Christian monarchy. This symbolic framework also influenced the young Ignatius of Loyola, who witnessed it firsthand at the Spanish court.
Keywords
Gerusalemme, Riconquista, monarchia universale, profezia, Ignazio di Loyola.
Jerusalem, Reconquista, Universal Monarchy, Prophecy, Ignatius of Loyola.
È generalmente riconosciuto che Gerusalemme ha avuto un ruolo importante nella vita di Ignazio di Loyola. Già nel 1521, mentre si stava riprendendo dalla ferita di guerra riportata durante la battaglia di Pamplona nel castello paterno, pensò a un pellegrinaggio a Gerusalemme. Questa riflessione costituì il punto di partenza per il discernimento degli spiriti, processo che sarebbe stato essenziale per la sua spiritualità. Dopo il soggiorno a Manresa, nel 1523 viaggiò da Barcellona a Gerusalemme passando per Roma e Venezia. Il 15 agosto 1534, i primi sette compagni fecero un voto privato in una cappella di Montmartre, a Parigi, impegnandosi a compiere un pellegrinaggio comune a Gerusalemme.
Tuttavia, va notato che nessuna testimonianza scritta di questi piani risale all’epoca degli eventi stessi. In altre parole, i racconti della tradizione si basano su fonti scritte risalenti a epoche successive di oltre un decennio di distanza dagli eventi stessi. Dal punto di vista del contenuto, queste fonti sono chiaramente orientate verso valori spirituali. Inoltre, è interessante notare che nella biografia di Ignazio scritta da Diego Laínez (1512-1565) nel 1547 trattando il tempo di convalescenza non si fa alcun accenno al progetto di Gerusalemme, mentre questo viene menzionato soltanto nella cosiddetta autobiografia compilata da Luis Gonçalves de Câmara nel 1553[1].
Infine, un altro importante elemento di Gerusalemme, attestato nella corrispondenza personale di Ignazio di Loyola, è il progetto di crearvi un collegio, che il santo mise in programma dopo la fondazione del collegio di Messina nel 1548. Nel 1554 ricevette l’autorizzazione pontificia a realizzare tre collegi a Cipro, Costantinopoli e Gerusalemme. Tuttavia, poco prima di morire, su consiglio di alcuni nobili, abbandonò definitivamente questo progetto. A differenza dei tre precedenti riferimenti a Gerusalemme, questo progetto si riflette direttamente nelle lettere contemporaneamente scritte. In questi documenti non si trova nessuna connotazione spirituale, ma piuttosto un riferimento ai piani strategici di espansione in Medio Oriente sotto l’egida di Carlo V, il quale intendeva proseguire la Riconquista in Spagna in senso imperiale e universale. Va tuttavia specificato che a questa dinamica si accompagnava anche una componente storico-salvifica e spirituale. La politica del tempo era caratterizzata da interpretazioni storico-teologiche, soprattutto nell’ambiente della corte spagnola.[2]
In questo contesto, bisogna anche considerare che nel 1510 Giulio II (1503-1513) nominò Ferdinando d’Aragona (1452-1516) re di Gerusalemme. Naturalmente, questo atto non ebbe alcun impatto sulle condizioni effettive della città santa, ma confermò il programma militare di conquiste in Nord Africa, che sarebbero proseguite in direzione escatologica verso Gerusalemme dopo la presa di Granada nel 1492.[3] La Penisola iberica non ha una storia di crociate bassomedievali con delle spedizioni in Terra Santa. Tuttavia, all’inizio dell’età moderna, intorno di questa nomina ha adottato una narrazione di crociata per dare alla propria politica una dinamica specifica. Cosa ancora più importante per noi, Ignazio di Loyola era un giovane paggio vicino alla corte reale all’epoca di questi avvenimenti, quindi ne fu testimone diretto.
Queste osservazioni introduttive ci spingono a guardare indietro al tardo Medioevo spagnolo e a cercare i contenuti a cui il termine «Gerusalemme» era associato. È probabile che Ignazio ne sia stato influenzato durante la sua giovinezza e la sua formazione.
La Spagna sotto il trauma della conquista araba
Per tutto il Medioevo, la Spagna visse con il peso della conquista araba, iniziata nel 711 e che in pochi anni portò l’intera penisola sotto il dominio musulmano, ad eccezione di alcune ristrette regioni del nord. Nel corso dell’XI secolo, i re cristiani svilupparono una nuova identità intensificando i legami con la nobiltà borgognona, il monachesimo di Cluny e il papato. Contemporaneamente, il sud musulmano iniziò, con decisione crescente, a orientarsi verso il Nordafrica. I cristiani, che in precedenza avevano coltivato una tradizione mozarabica basata sull’eredità visigota, la sostituirono con un nuovo orientamento verso Roma. I musulmani, invece, fino a quel momento avevano letto anche la letteratura cristiana autoctona, come quella di Isidoro di Siviglia, in traduzione araba, ma ora questa veniva sempre più eliminata dai loro orizzonti. La creazione di due blocchi si accompagnò a una lenta avanzata dei cristiani verso sud.
Già nell’XI secolo fu elaborato uno schema soteriologico per legittimare le azioni belliche. Secondo tale schema, il cristianesimo si era sviluppato in una chiesa fiorente sotto l’influenza della grazia divina. Tuttavia, a causa di un rilassamento della fede, questa crescita è caduta in uno stato di stagnazione. Di conseguenza, Dio ha ritirato la sua grazia e, come punizione, ha scelto un popolo – non migliore, ma peggiore – come flagello e gli ha fatto conquistare la Spagna. Successivamente, nell’XI secolo, Dio restituì la sua benevolenza ai cristiani e diede loro il potere di scacciare i musulmani e di far rinascere la cultura e la società cristiane di un tempo. La Riconquista fu quindi dichiarata come la restituzione divinamente voluta dei territori persi a causa di una negligenza nella fede. Questo schema ebbe un profondo impatto sull’autostima della Spagna nell’Alto e nel Basso Medioevo e anche Papa Urbano II (1088-1099) lo utilizzò per legittimare la crociata che indisse nel 1095 e che si concluse con la conquista di Gerusalemme nel 1099.[4]
A metà del XIII secolo, i regni cristiani erano riusciti a sottomettere vaste zone della Spagna. La Castiglia ottenne grandi successi con le conquiste di Cordova (1236) e Siviglia (1248). Anche l’Aragona espanse il suo territorio a scapito dei musulmani, ma acquistò importanza soprattutto grazie all’incorporazione del Regno di Napoli-Sicilia nel 1282. I musulmani, d’altra parte, vennero ridotti a uno Stato di rango, con centro a Granada, che non costituiva più una vera minaccia politica ma che riuscì a sopravvivere altri due secoli fino al 1492. Tuttavia, questa espansione non fu un processo lineare e non portò a un’alleanza di principio tra le corone cristiane; al contrario, ci furono anche tensioni tra loro, uno dei cui risultati fu la creazione del Regno del Portogallo nel 1143.[5] In questi regni, sia i musulmani che gli ebrei continuarono a essere tollerati e poterono persino ricoprire importanti incarichi sociali o amministrativi. Tuttavia, il trauma dell’occupazione musulmana persisteva nella mentalità spagnola.
Arnaldo de Villanueva
In questo contesto merita una menzione speciale Arnaldo de Villanueva (1238-1311). Nato molto probabilmente a Villanueva, nei pressi di Saragozza, quando era ancora bambino la sua famiglia si trasferì nella regione di Valencia, da poco conquistata dal re d’Aragona. Arnaldo si dimostrò particolarmente leale alla Corona d’Aragona e si fece un nome come medico di re e papi. I suoi scritti di medicina circolarono in tutta l’Europa centrale e occidentale durante il tardo medioevo. Nel corso dell’espansione aragonese nell’Italia meridionale, entrò in contatto con alcuni spirituali francescani, che si orientavano alla tradizione delle riflessioni storico-teologiche di Gioacchino da Fiore (ca. 1130-1202) e promuovevano una riforma della Chiesa criticando le ricchezze della gerarchia. Come modello guida, seguivano il parallelismo tra il re Davide dell’Antico Testamento, che fece del popolo d’Israele un regno, il Cristo-Davide del Nuovo Testamento e il futuro Davide che avrebbe guidato l’intera cristianità in una nuova era dello Spirito Santo. Alcuni hanno visto in questo terzo Davide Francesco d’Assisi o Federico II, re degli Hohenstaufen.[6]
Arnaldo de Villanueva adottò questo modello sotto l’impronta del successo della Riconquista in Spagna, da un lato, e della perdita vergognosa di Tripoli nel 1288 e di San Giovanni d’Acri nel 1291 dall’altro, eventi che posero definitivamente fine alla presenza dei crociati in Terra Santa. Ma de Villanueva applicò questo schema all’Aragona, diventando così il padre del gioachimismo spagnolo. Egli vedeva questo terzo Davide in un futuro re d’Aragona, che alla fine, in un orientamento escatologico, avrebbe espulso i musulmani da tutta la Spagna, si sarebbe spostato in Nordafrica e passando verso l’Oriente avrebbe conquistato Gerusalemme, dove avrebbe instaurato una monarchia cristiana universale con l’aiuto attivo di ebrei battezzati. Questa profezia non divenne mai dottrina ufficiale e fu addirittura condannata a Tarragona nel 1316. Tuttavia, ciò non la fece scomparire.
In questo periodo, l’Aragona iniziò anche a rivendicare l’egemonia nel Mediterraneo, aprendo così la visuale verso Gerusalemme. Conseguentemente, nei due secoli successivi, la missione speciale di un re aragonese, l’idea delle crociate, la vittoria sui musulmani, gli ebrei convertiti e Gerusalemme divennero topoi che accompagnarono le riflessioni sull’identità della Spagna. L’applicazione e l’integrazione di queste idee aiutavano a superare il complesso d’inferiorità di non aver partecipato alle crociate; cioè l’ideale crociato ricevette in Spagna nel tardo medioevo quella grande forza che non aveva plasmato la mentalità nel tempo classico delle crociate.[7]
La Castiglia, invece, fin da Alfonso X (1252-1284), sviluppò l’ideale di restaurare l’unità originaria del regno visigoto, distrutto dagli arabi nell’VIII secolo. Alla fine del XIV secolo, questa visione castigliana si combinò con quella aragonese, dando origine a un’idea di unità e di monarchia universale a Gerusalemme che divenne specificamente spagnola.[8] Tuttavia, i due regni non riuscirono a sviluppare una vera politica imperiale a causa della Riconquista ancora incompleta. Nei circoli castigliani, quindi, «Gerusalemme» veniva spesso usata come metafora di Granada, che a sua volta si caricava di elementi escatologici.
La nazione marittima del Portogallo
Il Portogallo era il regno iberico che ben presto intraprese spedizioni verso l’Africa settentrionale attraverso l’Atlantico. Nel 1319, dei cavalieri fondarono «l’Ordine dei Cavalieri del Nostro Signore Gesù Cristo», il cui scopo era combattere l’Islam sui mari. Di solito, il Gran Maestro era il re. Nel corso del XV secolo, l’Ordine ottenne la conferma papale e numerosi privilegi che gli conferirono gradualmente la giurisdizione sui territori conquistati, il mandato di cristianizzare le popolazioni locali e di creare un’infrastruttura ecclesiastica, la fondazione di parrocchie e diocesi e la nomina di personale ecclesiastico, cioè religiosi, sacerdoti e vescovi. Dal 1486 fino al 1508 i papi concessero in diversi passi successivi gli stessi diritti anche alla Spagna. Questi percorsi diedero origine al patronato portoghese e spagnolo, il che significa che, da quel momento in poi, tutte le faccende ecclesiastiche d’oltremare furono trasferite alle due corone per mandato papale.[9]
Una pietra miliare nella storia del Portogallo fu la conquista della città nordafricana di Ceuta nel 1415, che avrebbe dovuto essere il preludio alla creazione di una via commerciale attraverso il Mar Rosso fino all’India passando per il Nordafrica. Questo tentativo si rivelò impossibile, per cui la strategia si spostò sulle spedizioni lungo la costa occidentale dell’Africa, sempre alla ricerca di una rotta marittima verso l’Oriente. Fu così che il Portogallo sviluppò un fiorente commercio a lunga distanza nel corso del XV secolo. A ciò era strettamente legato anche il progetto di cercare in Oriente le antiche comunità cristiane e il leggendario Prete Gianni, che si riteneva si trovasse in Etiopia. Insieme a questi, i re del Portogallo, in particolare Manuele I (1491-1521), volevano pugnalare alle spalle i musulmani, sconfiggerli e poi avanzare vittoriosamente verso Gerusalemme per stabilirvi una monarchia cristiana universale, come previsto dalla profezia di Villanueva.[10] Entrambe le dinamiche, quella del patronato e quella della strategia portoghese testimoniano un’importanza crescente dei laici nell’ambito missionario e generalmente nelle dimensioni religiose. Sono però anche essenziali per comprendere lo sviluppo della Compagnia di Gesù, soprattutto perché Ignazio pose anzitutto i suoi confratelli come missionari al servizio della corona portoghese.
Ulteriori sviluppi nel XV secolo
Nel corso del XV secolo si verificarono diversi eventi e sviluppi non direttamente correlati tra loro, che comunque portarono a una dinamica una dinamica concentrata con diverse sfaccettature.
Prima del 1492, circa un terzo della popolazione ebraica aveva abbracciato il Cristianesimo. Da una parte, si può osservare un approccio sempre più aggressivo, soprattutto da parte dei domenicani, che portò anche a dichiarazioni antiebraiche e a scontri. D’altra parte, gli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo godevano di una protezione speciale già dall’epoca del re castigliano Alfonso X, come stabilito nel codice Siete Partidas, che apriva loro interessanti percorsi di carriera. L’esempio più significativo è quello del rabbino capo di Burgos, Salamón Ha-Leví, che divenne cristiano nel 1390, vescovo di Cartagena nel 1401 e finalmente di Burgos nel 1415. Anche due dei suoi figli diventarono chierici e raggiunsero una notevole carriera.
Un possibile motivo per la conversione di tanti ebrei durante il XV secolo poteva essere la delusione delle aspettative messianiche. Per questa ragione, gli ebrei battezzati, numerosi e per lo più educati, portarono le loro idee messianiche nella Chiesa, combinandole con le aspettative delle corone. Cresceva anche nella popolazione spagnola la convinzione che la conversione degli ebrei fosse il primo passo dell’unione di tutta l’umanità in un solo gregge, che si poteva manifestare in una maggiore pressione a battezzarsi, ma anche in una maggiore stima e integrazione vincolante nella società cristiana.[11]
Inoltre, nel 1453 Costantinopoli fu conquistata dai turchi. Dal punto di vista politico, l’evento non ebbe un impatto immediato sulla Spagna. Ciononostante, l’evento ebbe enormi conseguenze mentali, soprattutto perché l’imperatore di Bisanzio era considerato nell’Europa centrale e occidentale come il successore di Costantino, e quindi dotato di una dignità speciale e della benedizione divina.
L’Europa cristiana ne fu traumatizzata e si diffuse il timore di una rinnovata potenza dei musulmani, timore che trovò conferma nelle ulteriori conquiste del periodo compreso tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo: Otranto (1480), Belgrado (1521), Rodi (1522) e la sconfitta degli ungheresi a Mohács, (1526) e l’assedio di Vienna (1529 e 1532). Ovviamente questo avanzamento aveva un impatto particolare nella Spagna, dove si temeva che i turchi potessero allearsi con il Regno di Granada e tornare a rappresentare una seria minaccia.[12]
Connessioni dinastiche ed espansione
La Spagna entrò in una nuova era con il matrimonio tra Isabella di Castiglia (1451-1504) e Ferdinando d’Aragona (1452-1516) nel 1469. I due regni continuarono a esistere, ma da quel momento in poi furono governati dallo stesso sovrano. Si può quindi affermare che, a partire da quel momento, la Penisola iberica, con l’eccezione del Portogallo e di Granada, era unita con il Regno di Napoli-Sicilia, importante dal punto di vista economico e culturale. Ferdinando e Isabella, e i loro successori, furono d’ora in poi chiamati «reyes catolicos» e si videro quindi come rappresentanti speciali di un cattolicesimo orientato a livello globale. Gli obiettivi spagnoli erano generalmente identificati direttamente con il cristianesimo.
Sullo sfondo di questi eventi, è comprensibile che la conquista di Granada da parte di Ferdinando d’Aragona nel 1492 sia stata interpretata come un evento di portata salvifica. Dopo la umiliante sconfitta dei cristiani a Costantinopoli, essi riuscirono a espellere i musulmani come sovrani politici dall’Europa meridionale e occidentale. Quando, nello stesso anno, agli ebrei fu data la possibilità di scegliere tra il battesimo e l’emigrazione, si sentì l’eco diretta della profezia di de Villanueva, secondo la quale l’espulsione dei musulmani, la Spagna unita e gli ebrei battezzati sarebbero avvenuti in un contesto escatologico. In seguito, Ferdinando continuò le conquiste in Nord Africa. I successi furono scarsi e limitati alla presa di alcune città e fortezze, come Melilla (1509), Orán, Argel, Bugía e Tripoli (1510). Questi trionfi ebbero forse conseguenze economiche, ma non portarono alla formazione di un territorio sotto dominio spagnolo. Tuttavia, è evidente che Ferdinando voleva aprirsi la strada verso Gerusalemme, anche se i consiglieri comunali, in particolare quelli di Castiglia, non appoggiavano tali piani espansionistici, ma favorivano il consolidamento politico interno.[13]
La dinamica del matrimonio di Isabella e Ferdinando proseguì nel 1496 con il matrimonio della figlia Giovanna (1479-1555) con l’erede del trono asburgico Filippo il Bello (1478-1506), che non ebbe conseguenze immediate a causa della morte prematura di quest’ultimo. Tuttavia, i domini dei re cattolici e degli Asburgo furono collegati sotto Carlo V (1500-1558), che assunse anche la dignità imperiale nel 1519. In conseguenza, secondo delle considerazioni di ordine storico-teologico, avrebbe dovuto continuare la politica in riferimento a Carlo Magno e incorporare la Roma orientale nel suo impero, riportando così Costantinopoli e in un ulteriore passo anche Gerusalemme sotto il dominio cristiano.[14]
La pietà tardo-medievale
Proprio perché la Spagna non era in grado di sviluppare una politica crociata attiva a causa della Riconquista in corso, la predicazione crociata propagata dai papi Callisto III (1455) e Pio II (1463) fu legata a un crescente interesse spirituale per Gerusalemme. Soprattutto portarono a un aumento dei pellegrinaggi in Terra Santa, più facili da organizzare grazie alla politica tollerante dei musulmani. Inoltre, i pellegrini erano sotto la speciale protezione della Corona d’Aragona, che si rifletteva non solo nelle questioni logistiche, ma anche nell’intensa assistenza spirituale fornita dai francescani. Notevole anche che questo orientamento a Gerusalemme si collegava con una nuova stima della Santa Sede: cioè tutti i pellegrini dovevano prima richiedere l’autorizzazione e la benedizione del papa. Questi pellegrinaggi portarono alla stesura e alla stampa di numerosi resoconti di pellegrinaggio e diedero vita a nuove forme di pietà anche in Spagna. In alternativa ai viaggi a lunga distanza, le devozioni alla Via Crucis ebbero nuova popolarità, così come la contemplazione approfondita della vita di Gesù in una spiritualità personale.[15] Questi pellegrinaggi puramente interiori e queste contemplazioni individuali non possono mai essere completamente separati dal loro sfondo escatologico e politico. Tuttavia, anche in questo caso, è evidente quanto Ignazio fosse fortemente inserito in questo percorso tardomedievale, come dimostrano la lettura della Vita Christi del certosino Ludolfo di Sassonia (1377) sul letto di malattia e il suo pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1523 per cui si fermò a Roma per la benedizione pontificia.[16]
Il Nuovo Mondo
Al centro della visione del mondo spagnola del tempo moderno c’è la spedizione di Cristoforo Colombo nel 1492, con la quale la prima nave europea fece rotta verso il continente americano, evento concomitante alla conquista di Granada e all’espulsione degli ebrei che non si convertirono. La politica dei re cattolici a Granada e in Africa era quindi strettamente legata alla loro identità di patroni della Terra Santa e si svolgeva di pari passo con la loro pretesa messianica di diventare re di Gerusalemme. È importante notare che Colombo era molto vicino alla tradizione di Arnaldo de Villanueva ed era convinto che un re spagnolo avrebbe ricostruito Gerusalemme come città fortificata. Il suo viaggio era motivato anche dalla convinzione che la restaurazione del regno visigoto unificato avrebbe portato a nuovi contatti con una società cristiana nascosta in Oriente. Il topos di «Gerusalemme» non conteneva solo la rinascita della Spagna, ma anche la ricerca di comunità cristiane da riunire sotto la corona spagnola universalista e la cristianizzazione di culture ancora sconosciute, come aveva già procurato Marco Polo, laico e mercante.[17] «Gerusalemme» significava quindi un ritorno alle proprie radici spirituali, ma anche una partenza e un’avanzata verso un mondo ancora sconosciuto.
«Gerusalemme» per Ferdinando d’Aragona
Il re Ferdinando d’Aragona era fermamente convinto della sua missione messianica e approfondì questa consapevolezza nel corso del suo lungo regno. I suoi successi strategici e l’arrivo nel Nuovo Mondo ne furono la conferma, in quanto collegarono direttamente la ripresa dell’idea di crociata e il ritorno ai fondamenti della rivelazione cristiana con la partenza verso un futuro in gran parte sconosciuto. I suoi piani per Gerusalemme avevano anche una componente pragmatica: gli permettevano, infatti, di riscuotere una tassa di crociata autorizzata dal Papa. Le conquiste in Nord Africa sono la prova evidente che egli intendeva farlo sul serio. Costruì, infatti, una grande flotta, in primo luogo per difendere i possedimenti spagnoli in Italia, in secondo luogo per conquistare Tunisi e, in terzo luogo, per realizzare una crociata a Gerusalemme. Ferdinando allevò anche il figlio Juan (1478-1497) affinché un giorno diventasse re di Gerusalemme. Dopo la sua morte prematura, trasmette questa visione a sé stesso. La nomina papale a Re di Gerusalemme nel 1510 non fu quindi un episodio isolato, ma un anello di una lunga catena di eventi e di speculazioni storico-teologiche. Una beghina profetizzò che Ferdinando non sarebbe morto prima di aver conquistato Gerusalemme. Per questo motivo, nel 1516, poco prima di morire, rifiutò l’estrema unzione perché non vedeva ancora la sua fine, in quanto la profezia non si era ancora concretizzata. Anche molti spagnoli credettero in questa missione speciale dei re cattolici, e con loro di tutta la Spagna. Nel corso degli ultimi anni di Ferdinando, e ancor più sotto Carlo V, due elementi, ossia la monarchia universale e la consapevolezza di essere il popolo eletto, si staccarono dal termine «Gerusalemme», da cui erano originariamente emersi, e si combinarono con l’ideale dell’espansione nel Nuovo Mondo.[18]
Conclusione
Nel corso del tardo Medioevo, la Spagna creò una propria tradizione di Gerusalemme. Sulla base delle idee di Gioacchino da Fiore, si sviluppò la concezione di un re spagnolo che avrebbe fondato una monarchia universale a Gerusalemme. Questa idea influenzò la fase finale della Riconquista, ma anche la formazione di un’identità specificamente spagnola che, dopo la presa di Granada nel 1492, acquisì un dinamismo ancora maggiore e fu infine sottomessa all’espansione globale. Queste visioni e riflessioni storico-teologiche caratterizzarono anche il giovane paggio Ignazio di Loyola, che aveva trascorso diversi anni vicino alla corte spagnola prima di intraprendere il suo cammino spirituale, che lo portò alla fondazione di un ordine religioso globale.
Bibliografia
Cámara, González de. “Acta Patris Ignatii Scripta a P. Lud. González de Cámara (1553/1555).” In Fontes Narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis. Volumen I, narrationes scriptae ante annum 1557, 354-507, MHSI 66, Romae 1943.
__________ . “Epistola Patris Laynez de P. Ignatio (1547).” In Fontes Narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis. Volumen I, narrationes scriptae ante annum 1557, 70-145, MHSI 66, Romae 1943.
Cardini Franco, Musarra Antonio. Die grosse Geschichte der Kreuzzüge. Von den Soldaten Christi bis zum Dschihad. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2022.
Crowley, Robert. Die Eroberer. Portugals Kampf um ein Weltreich, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016.
Delgado, Mariano. “Die katholische Nation. Typologien einer vorsehungstheologischen Deutung der spanischen Geschichte.” In Gott in der Geschichte. Zum Ringen um das Verständnis von Heil und Unheil in der Geschichte des Christentums, 289-307. Stuttgart: Kohlhammer, 2013.
__________ . Das Spanische Jahrhundert (1492-1659). Politik – Religion – Wirtschaft – Kultur. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016.
García Hernán, Enrique. Ignacio de Loyola. Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2013.
Herbers, Klaus. Geschichte Spaniens im Mittelalter. Vom Westgotenreich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.
Ignatius von Loyola. “Der Bericht des Pilgers.” In Gründungstexe der Gesellschaft Jesu, 1-84, Würzburg: Echter, 1997.
Milhou, Alain. Colomb et le messianisme hispanique. Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2007.
-
González de Cámara, “Epistola Patris Laynez de P. Ignatio” e “Acta Patris Ignatii Scripta a P. Lud” in: Fontes Narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis, ed. D. Fernandes Zapico, C. de Dalmases, P. Leturia, Vol I, (Roma: MHSI, 1943), no. 66, 70-145, 354-507. ↑
-
Mariano Delgado, Die katholische Nation. Typologien einer vorsehungstheologischen Deutung der spanischen Geschichte (Stuttgart: Kohlhammer, 2013), 292-295. Enrique García Hernán, Ignacio de Loyola (Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2013), 405-407. ↑
-
Enrique García Hernán, Ignacio de Loyola (Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2013), 50-51. ↑
-
Franco Cardini e Antonio Musarra, Die grosse Geschichte der Kreuzzüge. Von den Soldaten Christi bis zum Dschihad (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2022), 24. ↑
-
Klaus Herbers, Geschichte Spaniens im Mittelalter. Vom Westgotenreich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts (Stuttgart: Kohlhammer, 2006), 203. ↑
-
Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 318-321. ↑
-
Mariano Delgado, Das Spanische Jahrhundert (1492-1659). Politik – Religion – Wirtschaft – Kultur (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016), 4. Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 27, 160, 272, 318-321. ↑
-
Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 304-309. ↑
-
Mariano Delgado, Das Spanische Jahrhundert (1492-1659). Politik – Religion – Wirtschaft – Kultur (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016) 17-18; Klaus Herbers, Geschichte Spaniens im Mittelalter. Vom Westgotenreich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts (Stuttgart: Kohlhammer, 2006), 289-297. ↑
-
Robert Crowley, Die Eroberer. Portugals Kampf um ein Weltreich (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016) 184-198, 328-344. Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2007). 139. ↑
-
Klaus Herbers, Geschichte Spaniens im Mittelalter. Vom Westgotenreich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts (Stuttgart: Kohlhammer, 2006), 307f. Mariano Delgado, Das Spanische Jahrhundert (1492-1659). Politik – Religion – Wirtschaft – Kultur (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2016), 43f.; Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 141-147. ↑
-
Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 18-20, 279. ↑
-
Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 283. ↑
-
Mariano Delgado, Die katholische Nation. Typologien einer vorsehungstheologischen Deutung der spanischen Geschichte (Stuttgart: Kohlhammer, 2013), 295-297. ↑
-
Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 23, 150, 262. ↑
-
Ignatius von Loyola, “Der Bericht des Pilgers”, in Gründungstexe der Gesellschaft Jesu, ed. Peter Knauer (Würzburg: Echter, 1997), 16, nota 37. ↑
-
Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 151. ↑
-
Alain Milhou, Colomb et le messianisme hispanique (Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée, 2007), 330-339. ↑