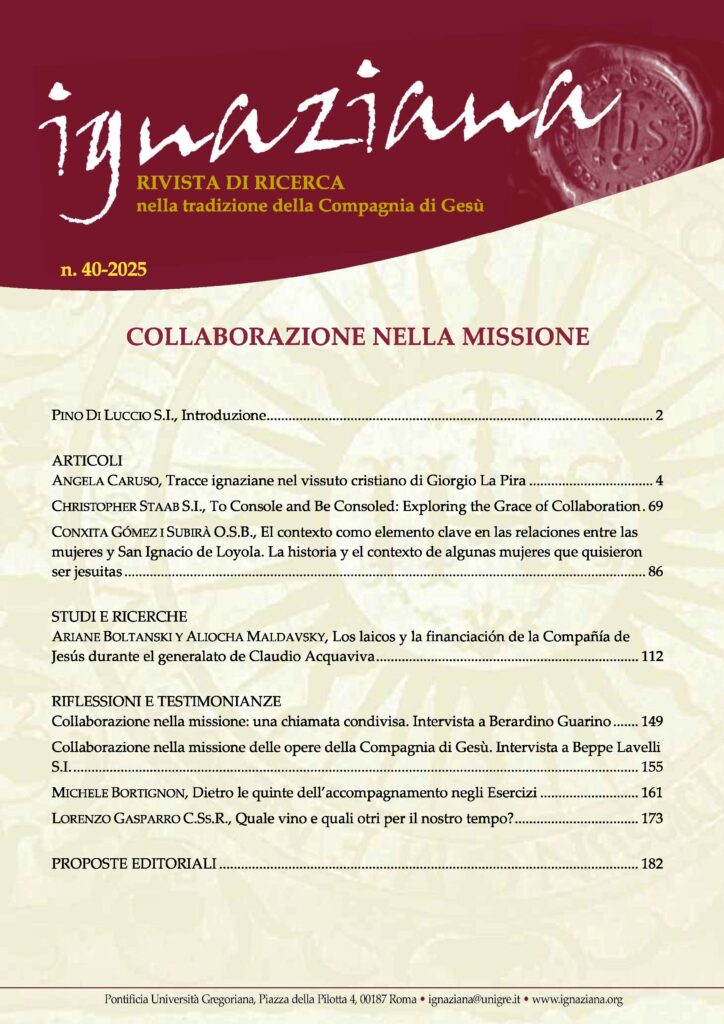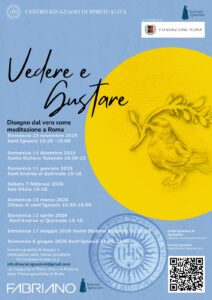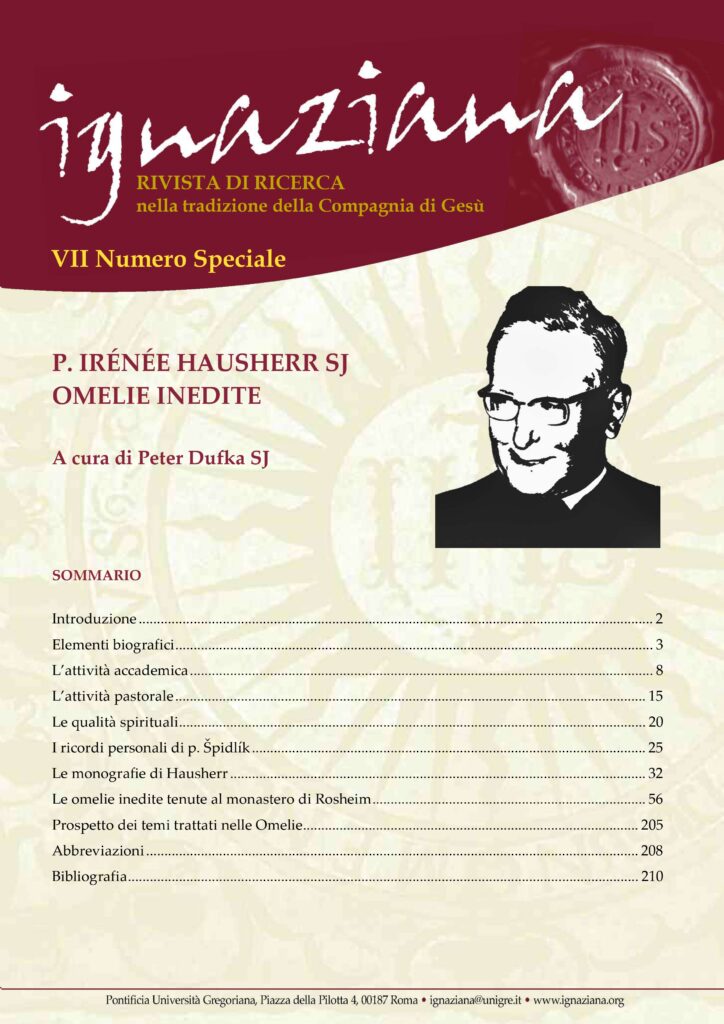Abstract
L’articolo esplora il valore contemplativo dell’opera di Sant’Ignazio di Loyola, evidenziandone la rilevanza sia nella tradizione mistica medievale sia nel contesto spirituale contemporaneo. L’autore sostiene che il pensiero ignaziano rappresenti una vera e propria “scuola di contemplazione”, capace di integrare riflessione intellettuale e preghiera immaginativa, rispondendo così al crescente bisogno di semplicità e interiorità del mondo postmoderno. Dopo un’analisi storica e metodologica, il testo approfondisce pratiche specifiche come l’examen, la contemplazione per raggiungere l’amore e il terzo modo di pregare. Particolare attenzione è dedicata al rinnovamento del XX secolo e al contributo del gesuita Franz Jálics, il cui metodo rende attuale l’approccio contemplativo ignaziano. Il saggio mostra come la spiritualità di Sant’Ignazio possa offrire risposte profonde alle sfide interiori dell’uomo contemporaneo, favorendo un incontro personale e trasformante con Dio.
The article explores the contemplative value of the Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola, highlighting their relevance both within the medieval mystical tradition and in the contemporary spiritual context. The author suggests that Ignatius’s work represents a true “school of contemplation,” capable of integrating intellectual reflection with imaginative prayer, and of responding to the growing need for simplicity and interiority in the postmodern world. Following a historical and methodological analysis of the Exercises, the text focuses on specific forms of prayer—including the examen, the contemplation to attain love, and the third method of prayer—emphasizing their affinities with Eastern ascetic practices. Particular attention is given to the 20th-century renewal and to the contribution of Jesuit Franz Jálics, whose method brings the Ignatian contemplative approach into the present day. The article shows how the spirituality of Saint Ignatius can offer profound answers to the inner challenges of contemporary humanity, fostering a personal and transformative encounter with God.
Keywords
Contemplazione, Preghiera immaginativa, Meditazione, Examen, Franz Jálics.
Contemplation, Imaginative prayer, Meditation, Examen, Franz Jálics.
Che cosa ha a che fare Sant’Ignazio di Loyola (1491-1556), il fondatore dell’ordine dei Gesuiti, con la meditazione e con la contemplazione? La risposta, ovviamente, dipende da cosa intendiamo con queste parole. Per molto tempo la persona e l’opera di Sant’Ignazio non sono state associate alla “contemplazione”, almeno nel senso contemporaneo del termine. In effetti, a partire dagli anni Sessanta, il concetto di contemplazione è entrato nel linguaggio occidentale – soprattutto sotto l’influenza delle culture e delle religioni dell’Estremo Oriente – per indicare un modo semplice e mistico di entrare in contatto diretto con Dio. Questo rappresenta un certo cambiamento rispetto all’uso semantico del termine, nel Medioevo[1]. Gli autori medievali erano soliti proporre una triplice distinzione: lectio, meditatio e contemplatio. Corrispondevano, rispettivamente a lettura delle Scritture, “meditazione discorsiva” su un testo (cioè l’immersione in un testo, la riflessione intellettuale, la comprensione e l’elaborazione razionale di essa e l’applicazione alla vita concreta) e preghiera attraverso l’uso dell’immaginazione[2]. In questo saggio, cerco di dimostrare che gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio sono una scuola di contemplazione[3] sia in senso medievale che moderno. Da un lato, possono essere d’aiuto ai cristiani contemporanei che cercano di mettere ordine nella loro vita e di praticare, a tal fine, la contemplazione intellettuale; dall’altro, poiché il bisogno di semplicità e di contemplazione sono in crescita, nel nostro mondo postmoderno accelerato, la tradizione spirituale di Sant’Ignazio può avere cose importanti da dire a chi è interessato alla tradizione contemplativa, in senso contemporaneo e orientale. Fino a qualche tempo fa, Sant’Ignazio è stato accusato di volontarismo, cioè di aver enfatizzato troppo l’importanza della volontà, oggigiorno questa presupposizione va rivista: è tempo di riconoscere i tratti mistici (contemplativi) del fondatore dell’Ordine del XVI secolo e dare voce al suo messaggio nascosto.
Nelle pagine che seguono, chiarirò brevemente la natura degli Esercizi Spirituali, per poi discutere in dettaglio i riferimenti alla contemplazione e il metodo dell’opera principale di Sant’Ignazio. Infine, esaminerò una particolare applicazione (quella contemplativa) degli Esercizi Spirituali che è associata al nome di Padre Jálics. La mia tesi di fondo, come suggerisce il titolo del saggio, è che gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio possono essere considerati una scuola di contemplazione (sia nel senso moderno che medievale del termine).
Cosa sono gli “Esercizi Spirituali” ?
Gli Esercizi Spirituali[4] di Sant’Ignazio, caratterizzano in maniera distintiva sia la sua persona che l’Ordine da lui fondato, la Compagnia di Gesù. Si tratta, infatti, di una raccolta di risorse per persone che cercano di approfondire la propria vita cristiana e di aiutare gli altri a farlo. Gli Esercizi Spirituali sono stati scritti probabilmente proprio per quest’ultimo “gruppo di riferimento”: erano stati pensati come guida per l’animatore (direttore, accompagnatore) di un ritiro, di circa trenta giorni, in completo silenzio e solitudine. Si tratta di un testo relativamente breve, conciso e ricco di contenuti, che, come nota san Francesco di Sales, “ha salvato più anime di quante lettere contiene”[5]. Il volume, approvato e raccomandato per l’uso ecclesiastico da Papa Paolo III nel lontano 1548[6],vanta una lunga storia di significativa influenza. Va detto che chi prende in mano gli Esercizi Spirituali per la prima volta, potrebbe scontrarsi con una lettura arida. Infatti, Sant’Ignazio fornisce un programma di massima e delle tecniche di preghiera – con alcune “note” (annotazioni, anotatios), oltre a “preambuli” (preambulos, presupuestos) e consigli pratici – per aiutare la persona che fa gli Esercizi Spirituali a “vincere se stesso e [per] mettere ordine nella propria vita” (Es. 21) e per “fare una buona e sana scelta” (Es. 178) in accordo con la volontà di Dio (cfr. Ess. 169-188; spec. 184-187). Come già detto in precedenza, sebbene gli esercizi siano divisi in quattro Settimane, il testo stesso ne incoraggia esplicitamente la loro applicazione secondo le circostanze – “in relazione alla condizione delle persone [che li prendono] e cioè secondo l’età, l’istruzione o l’ingegno che hanno” (ess. 4; 18-19, qui: 18). Ignazio ci aiuta a comprendere il tenore del suo libro con un’analogia metaforica, impiegata già all’inizio, nella prima nota: come gli esercizi “corporali”, quali “il passeggiare, il camminare, il correre” promuovono la salute generale del corpo, così gli “esercizi spirituali” promuovono la libertà dalle “affezioni disordinate” e un’autentica relazione con Dio, che consiste nel vivere una vita umana in accordo con il fine ultimo della creazione di Dio (cfr. Es.1).
Nelle prime pagine degli Esercizi spirituali troviamo un’affermazione cruciale che può fornire una chiave di lettura del loro significato. Formalmente, si tratta di una prescrizione utile per chi dà gli esercizi (o, come oggi viene giustamente chiamato, dell’“accompagnatore”), ma il suo significato va ben oltre la semplice regola: rivela una convinzione teologica radicata, giustamente considerata rivoluzionaria ai tempi di Sant’Ignazio. La nota dice che la persona che dà gli esercizi deve stare accanto alla persona accompagnata in modo che “lasci operare [direttamente] il Creatore con la creatura e la creatura con il Suo Creatore e Signore” (Es. 15). Il compito dell’accompagnatore, quindi, è di non prendere posizione. Ignazio afferma chiaramente che “non propenda, né si inclini verso l’una o verso l’altra parte” (ibidem). Dunque, la sua mansione è fare spazio all’azione di Dio (facilitandola e non ostacolandola). La vera novità, introdotta da Sant’Ignazio, è considerare la preghiera (o l’esercizio spirituale) come un contatto “diretto” (sin intermediario) con Dio. Così, come mostra il testo delle Costituzioni,[7] Sant’Ignazio non si affida principalmente ad alcuna tecnica o strategia, ma basa i suoi Esercizi spirituali sulla fiducia che Dio (che è “Creatore e Signore”) sia in grado di guidare e rivolgersi alla persona che fa gli esercizi (la “creatura”) nella preghiera personale anche senza alcuna istituzione o mediazione da parte di altre persone (chiesa o sacerdoti)[8]. Sebbene Ignazio non approfondisca cosa intenda esattamente con questa “immediatezza”, tutto il suo programma ruota attorno a questa convinzione[9]. Abbiamo già detto che la contemplazione, in senso moderno, significa un rapporto semplice e diretto con Dio, ma questo è ben lontano dal senso in cui viene utilizzato il termine nel testo degli Esercizi Spirituali. Lo esamineremo più da vicino.
Il significato di “contemplazione” negli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio
Sant’Ignazio visse nel XVI secolo, al crocevia tra il Medioevo e l’età moderna. Non sorprende, quindi, che quando distingue i termini “meditazione” e “contemplazione”, negli Esercizi Spirituali, attribuisca a queste parole un significato specifico che non corrisponde al nostro. Per lui, nel solco della tradizione medievale, “meditazione” (meditación) significa una forma di preghiera, in cui il praticante prega con pensieri e immagini. Per Ignazio, tale “meditazione” è, ad esempio, la meditazione sui peccati (Ess. 55-61), sull’inferno (Ess. 65-72), sul servizio di un Re temporale e del Re eterno (Cristo) (Ess. 91-100); sulle “due bandiere” (Ess. 136-148), o sulle “tre categorie di persone” (tres binarios de hombres) (Es. 148) e altri argomenti simili[10]. Di contro, la parola “contemplazione” (contemplación) si riferisce tipicamente alla contemplazione dell’attività di Dio nella storia, con i nostri occhi spirituali.
Secondo Sant’Ignazio, Dio può essere scoperto nella storia in almeno due modi. Da un lato, la sua azione può essere riconosciuta nella storia della vita di Gesù Cristo – la sua incarnazione (Ess. 101-109), la sua passione (Ess. 200-209), la sua morte e risurrezione (Ess. 218-229) – come apprendiamo dai Vangeli. Per Sant’Ignazio, questo significa “contemplare” le scene bibliche (cfr. Ess. 1-2; 12-13; 47-49; 74-77; 158-164, ecc.). D’altra parte, nel vocabolario degli Esercizi Spirituali (soprattutto negli esercizi della seconda, terza e quarta Settimana), anche le opere di Dio possono essere oggetto di “contemplazione” (contemplación), in quanto le vediamo manifestarsi nella creazione. L’esempio più noto è la “contemplazione” per “raggiungere l’amore” (Ess. 230-237), dove Sant’Ignazio ci invita a “considerare” e “contemplare” “come Dio lavora e opera per me in tutte le cose create sulla faccia della terra, come cioè si comporti da lavoratore nei cieli, negli elementi, nelle piante, nei frutti, nel bestiame ecc., dando l’essere, conservando, facendo vegetare, sentire ecc.” (Ess. 236). Naturalmente, come si può vedere dagli esempi di cui sopra, la differenza tra “meditazione” e “contemplazione”, in Sant’Ignazio, non deve essere esasperata, poiché in alcuni punti degli Esercizi Spirituali “meditatión” e “contemplatión” sembrano essere sinonimi (cfr. Es. 47; cfr. anche Ess. 2; 49).
Il metodo della “contemplazione di Sant’Ignazio” inizia tipicamente con una preghiera preparatoria, in cui l’orante chiede la grazia che, nel corso della preghiera, tutto sia fatto a maggior gloria di Dio. Seguono tre preludi, una sorta di esercizio preparatorio in cui (a) l’orante ricorda innanzitutto il racconto evangelico; (b) poi, attraverso l’immaginazione, si colloca nella scena con cui sta per pregare (nel linguaggio tradizionale dei gesuiti, questa è la composición de lugar, “la costruzione visiva del luogo” o “la composizione, vedendo il luogo”) (cfr. Ess. 47; 55; 65; 91; 103; 112; 138; 151; 192; 220; 232); (c) infine, una breve preghiera in cui l’esercitante chiede la grazia che ritiene necessaria (“Chiedo ciò che voglio”: cfr. Ess. 65; 104; 139; 152; 203; 233). Il testo degli Esercizi Spirituali suggerisce, infine, tre “punti” o “preamboli” (preámbulos) da tenere in considerazione nell’esecuzione della preghiera. Questi, per quanto si può ricostruire dai testi esemplificativi all’inizio della seconda, terza e quarta Settimana, in genere (a) sollecitano, prima, una rappresentazione immaginaria della persona nella scena; (b) poi chiedono di ricordare ciò che la persona sta dicendo; (c) infine, ricordano alla persona ciò che sta facendo[11]. In modo cruciale, tutti i “preamboli” della “giornata” definita da Sant’Ignazio – e anche le preghiere con le applicazioni dei sensi[12] – si concludono con l’invito a cercare di “trarne qualche profitto” (sacar algún provecho) dalla contemplazione (Ess.194; cfr. 106-108; 114-116; 122-125; 238; 362). Lo scopo di ogni riflessione e contemplazione è, quindi, quello di discernere sempre più chiaramente come seguire Cristo nel modo migliore e più radicale[13]. Tutto questo sembra piuttosto astratto per chi non ha fatto esperienza di esercizi ignaziani. Alcuni esempi possono aiutarci a capire.
La “costruzione visiva del luogo” (composición de lugar)
Negli Esercizi Spirituali, l’elemento essenziale delle preghiere (meditazione, contemplazione) con l’aiuto dell’immaginazione è sempre una certa ambientazione, la “composizione del luogo” (composición de lugar) [14]. È il passo iniziale quando si inizia la meditazione. Compito dell’orante è usare l’immaginazione per elaborare il più possibile i dettagli del luogo, in cui si svolgerà la scena evangelica e poi, sempre con l’immaginazione, visualizzare la scena di cui ha letto nel Vangelo e sulla quale, ora, vuole fare una preghiera meditativa o contemplativa. Ignazio invita l’orante a cercare di ricostruire, con l’ausilio della “vista immaginativa” (con la vista de la imaginación), l’oggetto e i soggetti della scena (lo “scenario”, per così dire) che i Vangeli ci presentano, fornendone dettagli concreti e vividi (cfr. Ess. 47). Sant’Ignazio si spinge molto in là nel consentire l’uso dell’immaginazione. Suggerisce, ad esempio, che nella “contemplazione sulla Natività” (Ess. 110-117) il devoto “vede […] con gli occhi dell’immaginazione la via da Nazareth a Betlemme, considerandone la lunghezza e la larghezza, se tale via è pianeggiante o se attraversa valli o alture” (Es.112), e allo stesso modo ‘contempla’ (mirar) il luogo della nascita, la grotta, “vedere quanto sia grande o piccolo, basso o alto e come tale luogo sia arredato” (Es. 112), e simili. Un altro esempio: nel contemplare l’Ultima Cena, l’esercitante è incoraggiato a immaginare la sala, “se è grande o piccola, di una maniera o di un’altra” (Es. 192). Da tutto ciò, risulta chiaro che per Ignazio non è importante l’autenticità storica dei dettagli immaginati (che un uomo moderno imbevuto di critica storica sarebbe portato a pretendere), ma piuttosto che, in questo modo, la scena evangelica si animi per la persona che fa gli esercizi spirituali. La persona che si “riappropria”[15] del Vangelo diventa, per esperienza vissuta, parte integrante del Vangelo. Per Sant’Ignazio, questa procedura aveva il chiaro scopo di far vivere al praticante un’esperienza personale dell’incontro con Cristo. A tal fine, l’attività creativa dell’immaginazione (che può fornire il materiale per questo incontro) non solo è consentita, ma addirittura raccomandata e auspicabile. Occorre riconoscere che la “ricostruzione vedendo il luogo” è solo una sorta di set per la riflessione. Proprio come in uno spettacolo teatrale, la scenografia è usata per rappresentare l’azione drammatica, così nella riflessione, che è la parte principale della preghiera, l’immaginazione può essere usata come mezzo di connessione personale per la persona che fa il ritiro. È importante ricordare che l’intera dinamica degli Esercizi Spirituali si svolge nel contesto della fede. È per questo che chi appartiene alla spiritualità di Sant’Ignazio osa, generalmente, confidare nel fatto che gli atti immaginativi non sono solo opere della nostra immaginazione, ma anche opere della guida dello Spirito Santo. È lo stesso Spirito divino che accompagna il praticante nella preghiera (nota bene: anche usando la sua immaginazione!); l’accompagnatore umano è solo l’assistente dello Spirito Santo in questo viaggio[16].
L’examen, o “preghiera di attenzione amorevole”
Forse la preghiera ignaziana più caratteristica è il cosiddetto examen. Un tempo si chiamava “esame di coscienza”, ma nella letteratura spirituale moderna è sempre più in uso il termine “preghiera di attenzione amorevole” (Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, prayer of loving attention). L’argomento si trova negli Esercizi Spirituali in due forme: come esame di coscienza “parziale” o “particolare” (examen particulare: Ess. 24-32), e come esame di coscienza “generale” (examen generale: Ess. 32-44). Questi sono descritti nel programma della prima Settimana, la fase in cui il penitente cerca di scoprire, il più profondamente possibile, la gravità dei propri peccati e, allo stesso tempo, la profondità della misericordia di Dio. Oltre agli esercizi spirituali personali, i gesuiti e i membri della “Famiglia spirituale di Sant’Ignazio” sono soliti praticare questa forma di preghiera una o due volte al giorno. Negli Esercizi spirituali, Sant’Ignazio individua cinque componenti dell’esercizio generale di coscienza: (1) ringraziamento, (2) richiesta di misericordia, (3) esame di coscienza, (4) pentimento e (5) propositi positivi per il futuro (cfr. Es. 43). Nel corso dei secoli, questo schema ha assunto la forma di una preghiera meditativo-contemplativa di circa quindici minuti, che permette al cristiano di verificare se è sulla strada giusta o se sta regredendo nel suo rapporto con Dio[17]. Come indicato sopra, nell’epoca moderna si è assistito a una trasformazione nella pratica dell’examen. L’esame di coscienza ha tradizionalmente significato la ricerca dei peccati. Non dobbiamo condannare i valori del passato per riconoscere che un certo spostamento di enfasi e l’emergere di nuove sensibilità possono essere giustificati. Per quanto il modo in cui Sant’Ignazio propone di condurre l’Examen possa essersi rivelato utile nella storia personale di salvezza di molti, c’era indubbiamente il pericolo che nel corso dell’esercizio ci si concentrasse solo sugli aspetti negativi della propria vita. Ciò poteva portare a una sorta di rigidità, scoraggiamento o disprezzo di sé, persino alla disperazione, e forse (in casi estremi) alla nevrosi religiosa. C’è anche il rischio che questa pratica richieda un grado di forza di volontà che poche persone possiedono. Nel 1972 fu pubblicato un importante articolo del gesuita George Aschenbrenner[18], che portò a un radicale ripensamento dell’examen. L’autore proponeva che l’esame si concentrasse sulla “coscienza” piuttosto che sull’“esame” della “coscienza”, incentrato sul peccato. Una positiva “attenzione” alla presenza di Dio – la “consapevolezza” – può aiutare a evitare le insidie psicologiche dell’esercizio. Piuttosto che concentrarsi esclusivamente su pensieri, parole e azioni peccaminose intenzionali, è più utile prestare attenzione ai “movimenti interiori” spontanei che non sono liberamente voluti, ma semplicemente sperimentati. L’enfasi viene, così, spostata dal senso di colpa e dalla subcoscienza alla consapevolezza della presenza e della coscienza di Dio: dal negativo al positivo, dal peccato alla grazia[19].
La “contemplazione per raggiungere l’amore” (contemplación para alcanzar amor)
La quarta settimana di Esercizi Spirituali contiene una “contemplazione” di grande respiro, profonda e bella, diretta “al raggiungimento dell’amore” (Es. 230-237). La riflessione inizia con due brevi “note” sulla natura dell’amore: l’amore si esprime nei fatti più che nelle parole e nello scambio reciproco tra le due parti (Es. 230-231). Chi pratica gli esercizi spirituali è, infine, invitato a immaginarsi alla presenza di Dio, dove gli angeli e i santi intercedono per lui o lei, e a chiedere a Dio l’“intima conoscenza” (conocimiento interno) dei beni ricevuti, per poter “in tutto amare e servire (en todo amar y servir) la sua divina maestà” (Es. 233). È solo, allora, che inizia la pratica vera e propria della preghiera. Sant’Ignazio prescrive quattro punti, ognuno dei quali richiama alla mente un diverso aspetto dell’attività di Dio: (a) in primo luogo, invita la persona che prega a ricordare i benefici che ha ricevuto (creazione, redenzione e altri doni più speciali). I tre ulteriori momenti di contemplazione consistono nel contemplare altre immagini: (b) Dio che abita nella creazione (Es. 235), (c) che lavora per noi (Es. 236) e (d) Dio che elargisce la sua bontà su di noi come i raggi del sole (Es. 237). Tutte queste considerazioni contemplative mirano a suscitare la stessa risposta da parte dell’orante: l’esperienza di “offrir[si] e donar[si]” “con molto affetto” alla “sua divina Maestà” (cioè “tutto ciò che ho e possiedo”: cfr. Es. 234). Alla fine, Sant’Ignazio propone una breve preghiera, solitamente chiamata Suscipe, dalla prima parola del testo ufficiale latino. È una sorta di Magna Charta della spiritualità gesuitica:
“prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo: tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono, tutto è tuo, disponine a tuo pieno piacimento, dammi il tuo amore e la tua grazia [o, secondo la traduzione ufficiale in latino, amorem tui solum cum gratia tua = amore per Te con la tua grazia], ché questa mi basta” (Es. 234).
Lo stile, l’intensità e la collocazione del testo (alla fine degli Esercizi Spirituali) suggeriscono che si tratti di un brano di grande enfasi, che può essere considerato una sorta di climax. Dopotutto, gli Esercizi Spirituali nel loro insieme erano destinati ad abbracciare la grazia dell’amore. Il contenuto di questa parte è anche solitamente associato all’esperienza mistica di Sant’Ignazio presso il fiume Cardoner[20]. Questa enfasi non è certo ingiustificata. Tuttavia, non ci sono indicazioni sul ruolo che lo stesso Sant’Ignazio intendeva attribuire a questo testo; il Direttorio ufficiale del 1599[21], e i documenti che lo preparavano, suggeriscono che i primi seguaci di Sant’Ignazio non gli attribuivano una particolare rilevanza. Solo gli interpreti più recenti ne hanno sottolineato l’importanza, tendendo persino a identificarlo con la “spiritualità ignaziana” tout court[22].
Il terzo modo di pregare (el tercer modo de orar)
Infine, in questo contesto, dobbiamo menzionare il “modo di pregare” che Sant’Ignazio raccomanda alla fine dei suoi Esercizi spirituali (cfr. Ess. 258-260). Esso è particolarmente significativo nella prospettiva che stiamo proponendo: il superamento della meditazione discorsiva verso la “contemplazione” in senso moderno. Infatti, se la nostra ipotesi è corretta, Sant’Ignazio ha effettivamente aperto la strada affinché i suoi Esercizi Spirituali possano essere considerati una “scuola” di contemplazione.
È sorprendente che alla fine della Quarta Settimana Sant’Ignazio parli di soli “tre modi di pregare” (tres modos de orar) (Es. 238), visto che, lungo il testo degli Esercizi Spirituali, sono presenti circa venti forme diverse di preghiera. Sarebbe fuorviante insinuare che ci sono solo tre modi (né più né meno) di pregare (quindi non è corretto tradurre il “Tre modi di pregare” con “I tre modi di pregare”). Il numero tre non esprime esclusività, data la logica del libro, ma si riferisce piuttosto a forme caratteristiche di preghiera che possono essere considerate paradigmatiche. Al termine del periodo di “su per giù in trenta giorni” di esercizi spirituali (cfr. Es. 4), il praticante può persino essere in grado di discernerle in base alla propria esperienza: dopo aver dedicato lunghe ore di intensa preghiera, può ora permettersi di decidere da solo quale forma gli è più utile. In questo senso, le forme di preghiera sono paragonabili a “tre rami dello stesso albero”, poiché “pur essendo diverse, sono animate dalla stessa linfa […] e sono molto adatte all’uso nella vita quotidiana, a partire dalle quattro settimane”[23]. Gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio si basano indubbiamente sull’esperienza: non sono deduttivi, ma induttivi (cioè tutto ciò che contengono deve essere applicato “in relazione alla condizione delle persone [che desiderano farli]” (Es. 18).
Proviamo a riassumere le “Tre modalità di preghiera” sopra citate. (1) Il “primo modo di pregare” insegna, senza dubbio, la preghiera discorsiva-intellettuale. Tutta l’antropologia teologica di Sant’Ignazio si riflette nel modo in cui invita a pregare prima sui dieci comandamenti (cfr. Es. 238-243), poi sui vizi capitali (cfr. Es. 244-245), sulle potenze dell’anima (cfr. Es. 246), sui cinque sensi corporali (cfr. Es. 247) e simili. In questa meditazione, la persona che fa gli esercizi usa prevalentemente le proprie voluntas e ratio, mentre il suo orizzonte si apre a Dio. Chi medita regolarmente in questo modo diventa gradualmente sensibile ai propri peccati e si esercita a guardare la propria vita con gli occhi di Dio: si apre gradualmente alla contemplazione nel senso di Sant’Ignazio.
(2) Il “secondo modo di pregare” è una forma più semplice della precedente: l’esercitante non lavora solo con il suo “cervello”. Si limita a recitare la preghiera, ad esempio il Padre Nostro o l’Ave Maria (cfr. Es. 256) – contemplando il significato di ogni parola della preghiera (contemplando la significación de cada palabra de la oración: Es. 249). Per chi prega con maggiore raccoglimento, l’esperienza dimostra che è sufficiente un numero minore di testi per aprire gli occhi sull’inesauribile ricchezza di ogni parola. Lo sforzo intellettuale viene, così, gradualmente sostituito dalla contemplazione, spesso colorata da caldi sentimenti per Dio. Lo dimostra la menzione nel testo degli Esercizi Spirituali della “devozione” (devoción) (Es. 252) che accompagna la preghiera, e del “gusto e consolazione” (gusto y consolación) (Es. 254) che è sempre più spesso coinvolto.
(3) Il “terzo modo” (tercer modo) di preghiera, ancora più semplice nella forma rispetto ai precedenti, riceve un’enfasi particolare nella descrizione di Sant’Ignazio (Ess. 258-260). Questo modo di pregare consiste nel ripetere “mentalmente”, al ritmo di inspirazione ed espirazione, una sola parola della preghiera, contemplando la differenza “tra l’altezza di quella [persona a cui si rivolge] e la propria bassezza” (Es. 258).
Quale può essere l’effetto di una preghiera eseguita in un modo così particolare, al ritmo dell’inspirazione e dell’espirazione, basata su una sola parola? Il ritmo armonioso del respiro crea una tensione vitale e una calma che ci invita a continuare. Di solito, si ottiene dolcezza, leggerezza e una sorta di presenza tranquilla che è uno stato d’animo e non un atto di volontà. L’effetto combinato delle componenti fisiche e spirituali può portare a un’integrazione e a una crescita che può evolvere in una vera armonia. In questo caso, si verifica un’assimilazione della personalità umana, che può non essere percepita dall’adoratore. Piuttosto, il cambiamento viene notato da coloro che lo circondano: essi riferiscono che l’orante è diventato più sensibile ai bisogni degli altri e ai propri. La sua presenza trasmette un senso di raccoglimento e di benevolenza. È una trasformazione combinata della mente e del cuore, tradizionalmente chiamata “conversione”.
Colui che vi cerca istruzioni tecniche, la cui precisa osservanza porterà al cambiamento, fraintende il testo di Sant’Ignazio. Non si tratta di un’autoredenzione! Non è la tecnica corretta che salva, ma Gesù Cristo, al cui amore l’orante è unito. L’essenza del terzo modo di pregare, quindi, risiede nell’abbandono fiducioso e nella resa incondizionata a sé stessi. L’esposizione disciplinata e regolare alla presenza di Dio porta inevitabilmente alla trasformazione: gli Esercizi Spirituali portano “frutti permanenti” sia nella preghiera che nella vita: a chi chiede l’amore di Dio e del prossimo, Dio glielo dona (cfr. Gv 15,16b). Ma questo non è più il premio dei nostri sforzi, bensì il dono gratuito di Cristo – la grazia.
La terza modalità di preghiera di Sant’Ignazio non è certo un’invenzione unica nel suo genere, ma è parte integrante della tradizione spirituale della mistica cristiana, che è esistita, come un fiume sotterraneo, in tutte le epoche. È facile tracciare paralleli, ad esempio, tra l’insegnamento di Sant’Ignazio sui modi di preghiera e i “nove modi di preghiera” (nueve modos de oración) di San Domenico Guzmán (1170-1221), anch’egli spagnolo e fondatore dell’Ordine dei Frati Predicatori (o Domenicani); e ci sono anche notevoli somiglianze con la Preghiera di Gesù (Иису́сова моли́тва) praticata dal pellegrino russo (divenuta popolare in Occidente nell’ultimo terzo del secolo scorso) [24]. Gli “starezi” della Chiesa d’Oriente si impegnavano nella preghiera perché volevano dare vita all’invito dell’apostolo Paolo alla preghiera incessante (1Ts 5,17). La loro preghiera tradizionale – “Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di me peccatore”, o qualche sua variante – era infatti una recita incessante di parole ispirate dalla Scrittura (cfr. Mt 1,21; Mc 10,48b). Questa preghiera rimarrà per sempre un tesoro inesauribile di teologia, poiché è in grado di riassumere in poche parole tutto il mistero di Cristo. Se è vero che la Preghiera di Gesù si compone di tre fasi – una fase “vocale”, una fase “spirituale” e una fase “del cuore” – allora possiamo anche notare che la terza modalità di preghiera di Sant’Ignazio (che per certi versi è il coronamento degli Esercizi Spirituali) le contiene tutte e tre.
La letteratura spirituale di Sant’Ignazio riconosce che il terzo modo di preghiera può essere messo in parallelo con forme di preghiera non cristiane. I seguaci delle grandi religioni dell’Asia conoscono e praticano bene la tradizione del “mantra”, che è anch’essa una forma di preghiera, eseguita al ritmo del respiro e, almeno da questo punto di vista esteriore, può essere senza dubbio associata al terzo modo di preghiera di Sant’Ignazio. Ma, forse, esiste anche un parallelismo più profondo! Infatti, la parola mantra, nel suo senso più ampio, significa qualcosa che aiuta a calmare lo spirito umano, cioè la contemplazione nel senso moderno (estremo orientale). Come le preghiere cristiane, il mantra ha lo scopo di evocare e mantenere un’associazione positiva: rappresenta un’immagine religiosa o una qualità della vita interiore e ci aiuta a dominarla. Nel suo senso autentico, quindi, non è destinato a produrre un effetto magico, né cerca di indurre artificialmente uno stato emotivo, ma di portare un seme per il futuro che, nel ritmo dolce del respiro, sorgerà e frutterà in abbondanza con la ripetizione: contribuirà all’interiorizzazione del suo contenuto. Questo è senza dubbio molto simile alla terza via di preghiera proposta da Sant’Ignazio[25].
L’edizione ufficiale italiana del 2002 del Libro degli Esercizi Spirituali (con approvazione ecclesiastica), tradotta e annotata da Giuseppe De Gennaro, richiama chiaramente l’attenzione sull’attualità del “terzo modo di pregare”. In una sintetica nota a piè di pagina leggiamo:
“Il terzo modo di pregare, basandosi sulla misura naturale del ritmo respiratorio, realizza un duplice vantaggio: 1. Disciplina, in senso rasserenante, il fatto fisiologico; 2. Mentre l’utilizza, incarna, in detto fondamentale schema della vita fisica, l’esperienza spirituale della preghiera. Questo modo di pregare, molto analogo ad alcune pratiche ascetiche orientali, è utilissimo e salutare particolarmente in momenti di concitazione tanto frequenti in epoche come la nostra”[26].
L’approccio aperto, ecumenico e interreligioso dei gesuiti di oggi ci incoraggia a collocare l’eredità spirituale di Sant’Ignazio in un contesto storico più ampio. In questo modo ci avviciniamo a fare luce sul senso in cui gli Esercizi Spirituali possono essere considerati come “scuola di contemplazione”.
In questo contesto, vale la pena ricordare brevemente il rinnovamento che ha portato a una significativa trasformazione degli esercizi spirituali di Sant’Ignazio nel XX secolo. Al posto (o in aggiunta) ai precedenti ritiri predicati, i gesuiti cominciarono sempre più a proporre e a condurre i cosiddetti “ritiri guidati individualmente”. Questa forma è in realtà una riscoperta della forma originale di esercizi spirituali praticati dallo stesso Sant’Ignazio di Loyola e dai suoi primi compagni.
Il processo si colloca nel contesto del rinnovamento teologico (intellettuale) e pastorale (spirituale) in atto all’interno del cattolicesimo romano. A metà del XX secolo, molti teologi cattolici ritenevano troppo rigida la tendenza neotomista dominante e il suo tentativo di rinnovamento. Uno degli strumenti di questo rinnovamento radicale è stato il ressourcement, ovvero il ritorno alle fonti: i rappresentanti della Nouvelle Theologie (Nuova Teologia), composta principalmente da teologi francesi e tedeschi[27], hanno cercato nuove strade da percorrere, rivitalizzando la Bibbia e la tradizione dei Padri della Chiesa. Queste correnti di ricerca culminarono nel Concilio Vaticano II (1962-1965) e furono ufficialmente confermate. Sullo sfondo di questi sviluppi, a metà del XX secolo, è iniziata un’intensa ricerca sulla storia della spiritualità, soprattutto nel mondo anglosassone. Il Boston College, negli Stati Uniti, si è distinto come uno dei centri di ricerca più insigni. Queste nuove riflessioni hanno portato a una radicale trasformazione nell’accompagnamento spirituale e nel modo di dare gli esercizi spirituali, attraverso la riscoperta di antiche forme.
Il movimento di rinnovamento della spiritualità ignaziana iniziò a porre l’accento anche sugli elementi mistici degli Esercizi Spirituali, fino ad allora poco discussi nei circoli gesuiti. C’erano, naturalmente, buone ragioni per questo silenzio: dapprima la minaccia dell’Inquisizione, che rendeva difficile il lavoro dello stesso Sant’Ignazio e, in seguito, le tendenze razionaliste della teologia del tomismo barocco e della neoscolastica resero difficile l’ascolto e la diffusione di tali voci. Sebbene i gesuiti, nella loro storia plurisecolare, non abbiano mai negato apertamente la possibilità dell’unione con Dio, l’enfasi è stata posta sulla disciplina ascetica nella preparazione e nell’esecuzione della preghiera, sulla necessità della disciplina e sui pericoli della possibilità di autoinganno. Con l’“aggiornamento” teologico del Concilio Vaticano II, la possibilità del contatto “diretto” (sin intermediario) (cfr. Es.15) e dell’incontro tra “il Creatore e la sua creatura” – questa idea centrale degli Esercizi Spirituali – non era più sospetta: gli ostacoli alla tematizzazione teologica erano in gran parte rimossi[28]. Alcuni interpreti cominciarono anche ad attribuire un’importanza centrale alla “contemplazione per raggiungere l’amore” (contemplación para alcanzar amor) (Ess. 230-237). Naturalmente, come tutti i cambiamenti spirituali, questo processo portò con sé delle conseguenze negative. Infatti, nella nuova prospettiva, i riferimenti alla disciplina gesuitica cominciarono ad apparire, nel migliore dei casi, alla luce di un fraintendimento accidentale (e nel peggiore, come un vero e proprio depistaggio, irrigidimento, ricaduta nel rigorismo preconciliare). Da tutte queste vicende, possiamo imparare una lezione importante: come tutte le altre identità, anche quella gesuitica è, in realtà, un costrutto. Nella storia profana e spirituale, anche i gesuiti reinterpretano, di volta in volta, la propria identità. È anche possibile che prospettive di epoche diverse coesistano in modo sincrono (il rinnovamento degli Esercizi Spirituali come “guidati dall’individuo” è ancora in corso). Vediamo ora un esempio di questo processo.
Un’applicazione contemporanea degli Esercizi Spirituali: gli esercizi spirituali contemplativi
Gli Esercizi Spirituali hanno chiaramente sempre avuto un ruolo centrale nella vita dei gesuiti e oggi non è diverso. Tuttavia, l’importanza non ha mai significato uniformità: nei quasi cinque secoli di storia dell’Ordine, gli esercizi di preghiera sono sempre stati adattati alle circostanze specifiche e sono stati applicati nella pratica in una grande varietà di forme[29]. Si potrebbe giustamente sostenere che questa pratica ermeneutica attualizzante ha reso possibile l’applicazione “contemplativa” degli Esercizi Spirituali in senso moderno.
Sebbene l’interesse per la mistica nella Chiesa sia talvolta andato in letargo, è sempre esistito. Anche se è stato oggetto di persecuzione da parte dell’Inquisizione, nel primo periodo moderno o durante il periodo del razionalismo illuminista, o tacciato di “illuminismo”, è sempre stato presente sotto forma di flusso dormiente. Sebbene Sant’Ignazio ne abbia potuto parlare solo di nascosto nei suoi Esercizi Spirituali, e ci siano voluti secoli perché il loro potenziale si dispiegasse, gli aspetti mistici della sua opera hanno potuto iniziare a diffondersi in un contesto culturale più favorevole. Oggi stiamo vivendo un periodo di questo tipo.
Oggi, stiamo indubbiamente assistendo a una rinascita globale del bisogno e dell’interesse per la contemplazione[30]. Alcuni maestri spirituali stanno ispirando i cristiani di tutto il mondo[31]. Tra questi c’è il gesuita di origine ungherese Franz Jálics (1927-2021), molto conosciuto e rispettato nel contesto europeo, che ha ribadito di nuovo la natura contemplativa degli Esercizi Spirituali. Jálics, che in precedenza aveva prestato servizio come missionario in Argentina (14 anni come insegnante di teologia e, contemporaneamente, 10 anni come direttore spirituale di studenti gesuiti), si trasferì in Germania nel 1978, dove fondò una casa di ritiro contemplativo (Haus Gries) a Gries (Oberfrank), nella Foresta Franca (Frankenwald), dove tenne ritiri contemplativi per migliaia di persone interessate tra il 1984 e il 2017. Nel 1994 ha pubblicato un libro sul suo metodo pratico di preghiera e di esercizi spirituali, intitolato Esercizi spirituali contemplativi[32], che ha venduto quasi 100.000 copie (finora tradotto in oltre una dozzina di lingue, tra cui il cinese; l’originale tedesco è stato pubblicato finora 16 volte). L’opera di Jálics ha avuto un impatto significativo in Germania, Austria, Svizzera, Ungheria e Argentina attraverso i suoi esercizi spirituali (che ha tenuto regolarmente anche in Ungheria dall’inizio degli anni ‘90) e i suoi numerosi libri[33]. Poiché il suo metodo è stato oggetto di molte critiche anche in ambito cattolico – persino gli stessi gesuiti lo hanno contestato con forza -, in due importanti articoli ha dimostrato che si tratta in realtà del “terzo modo di pregare” (tercer modo de orar) degli Esercizi spirituali (cfr. Ess. 258-260) che lo stesso Sant’Ignazio raccomanda a coloro che hanno già una certa esperienza nella vita di preghiera. Il metodo degli esercizi spirituali contemplativo di Jálics è quindi pienamente compatibile sia con la tradizione gesuitica e la spiritualità cristiana, sia con le Scritture. Resta solo una domanda fondamentale a cui rispondere: qual è il modo per praticarlo?
Bibliografia
Arzubialde, Santiago. “Tres modos de orar.” In Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Historia y análisis, 505–533. Bilbao–Santander: Mensajero–Sal Terrae, 2009.
Aschenbrenner, George. “Consciousness Examen.” Review for Religious 31 (1972): 14–21.
Bartók, Tibor. “Az ignáci lelkiség forrásai.” Accesso il 15 luglio 2025. https://adoc.pub/szasz-ludolf-vita-christi-2-ludolfo-de-sajonia-la-vida-de-cr.html.
Costituzioni della Compagnia di Gesù. Torino: UTET, [ebook].
De Gennaro, Giuseppe, cur. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali. Roma: Città Nuova, 2002.
Endean, Philip. “Contemplation.” In The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits, edited by Thomas Worcester. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
________. “Spiritual Exercises.” In The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits, edited by Thomas Worcester. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Tübingen: Mohr, 1960. Trad. it.: Verità e metodo. Milano: Bompiani, 1983.
Gallagher, Timothy. The Examen Prayer: Ignatian Wisdom for Our Lives Today. New York: Crossroad, 2006.
Giuliani, Maurice. “La via di Sant’Ignazio di Loyola. Un ritratto spirituale di opposizioni dialettiche.” La Civiltà Cattolica 4045 (5 gennaio 2019): 71–83.
Görföl, Tibor. A kritika hangja és a valóság szeretete: A kereszténység korunk európai kultúrájában. Budapest: Gondolat, 2018.
Hitter, József. “Bevezető a Lelkigyakorlatos könyvhöz.” In Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyve, 5–25. Budapest: Korda, 1940.
Pentkovskij, Aleksej, cur. Racconti di un pellegrino russo. Roma: Città Nuova, 1999.
Ignazio di Loyola. Racconto di un pellegrino. Introduzione, traduzione e note a cura di Giuseppe De Gennaro. Roma: Città Nuova, 2004.
Jálics, Franz. Impariamo a pregare. Una guida al dialogo con Dio. Roma: Edizioni Appunti di Viaggio, 2000.
________. Preghiera silenziosa e accompagnamento spirituale. Radici Evangeliche. Roma: Edizioni Appunti di Viaggio, 2017.
________. Kontemplative Exerzitien. Eine Einführung in die kontemplative Lebenshaltung und in das Jesusgebet. 12th ed. Würzburg: Echter, 2009. Trad. it.: Desiderio di Dio. Esercizi di contemplazione. Prefazione di Carlo Casalone e Silvano Fausti. Milano: Ancora, 2000.
Keating, Thomas. Divine Therapy and Addiction: Centering Prayer and the Twelve Steps. New York: Lantern Publishing & Media, 2010.
________. Intimacy with God: An Introduction to Centering Prayer. New York: Crossroad, 2009.
________. Open Mind, Open Heart: The Contemplative Dimension of the Gospel. New York: Continuum, 2002.
________. The Human Condition: Contemplation and Transformation. New York/Mahwah, NJ: Paulist Press, 1999.
Lambert, Willi. Aus Liebe zur Wirklichkeit: Grundworte ignatianischer Spiritualität. Mainz: Topos Plus, 2008.
Loyola, Ignazio di. Racconto di un pellegrino. A cura di Giuseppe De Gennaro. Roma: Città Nuova, 2004.
Ó Madagáin, Murchadh. An Evaluation and Critical Analysis of the Writing of Thomas Keating on Centering Prayer. Galway, 2005.
Rotsaert, Marc. Esercizi spirituali di sant’Ignazio: Storia, contenuto, metodo, finalità. Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2005.
Shea, Henry. “Composition of Place.” In The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits, edited by Thomas Worcester, 186. Cambridge – New York – Melbourne – Delhi: Cambridge University Press, 2017.
Standaert, Nicolas. “The Composition of Place: Creating Space for an Encounter.” The Way 46, no. 1 (2007): 7–20.
Tejerina, Ángel. “Modos de orar.” In Dizionario de espiritualidad ignaciana (G–Z), edited by José García de Castro, 1278–1282. Madrid: Mensajero – Sal Terrae, 2007.
________. “Tres modos de orar.” Manresa 69 (1997): 51–67.
- Sebbene il cambiamento di significato sia davvero notevole, la sua portata non deve essere esagerata. In effetti, contemplatio denota un rapporto mistico (diretto e semplice) con Dio già nei grandi autori cristiani del XII secolo (si vedano, ad esempio, le celebri definizioni di contemplazione di Ugo di San Vittore, Riccardo di San Vittore). Johannes Cassianus, che porta la tradizione monastica egiziana in Gallia alla fine del IV secolo, parla di questo tipo di preghiera in termini di ignita oratio, prex ignata e pura et sincera oratio (cfr. Conlationes IX-X), che contrassegna l’intera tradizione monastica occidentale fin dai suoi inizi. In questa luce, lo strato di significato descritto sopra come “moderno” è in realtà una riscoperta di una tradizione più antica (pre-medievale) che esisteva anche nel monachesimo occidentale. ↑
- Anche in questo caso, non si tratta di suggerire un contrasto netto. Ad esempio, nella Conlatio di Cassiano X, Isacco Abba dice della pura oratio: “Questa preghiera non solo non è oscurata dalla presenza di alcuna immagine, ma non è nemmeno disturbata dalla successione di alcun suono o parola (quae non solum nullius imaginis occupatur intuitu, sed etiam nulla uocis, nulla uerborum prosecutione distinguitur)” (X, n. 11, 413). La tradizione benedettina, che leggeva quotidianamente la Conlatio di Cassiano, ha indubbiamente mantenuto viva la tradizione della preghiera senza immagini e parole come contemplazione (e si presume che Sant’Ignazio stesso ne abbia sentito parlare nel monastero benedettino di Montserrat, che lo aiutò a
Nessuna fonte nel documento corrente.i Benedettini a introdurre l’uso dell’immaginazione mentale nella preghiera). ↑
- La “contemplazione” descritta negli Esercizi spirituali (cfr. ad esempio Ess. 101-117 ecc.) – come si discuterà più dettagliatamente in seguito – non può certo essere identificata senza ulteriori indugi con la “contemplazione” nel senso classico (antico e, in parte, medioevale) della tradizione monastica, perché contiene in misura considerevole elementi discorsivi. Tuttavia, secondo la nostra ipotesi di lavoro, il cosiddetto “terzo modo” della preghiera (Ess. 258-260) può essere considerato tale. Questa convinzione è anche alla base della teologia della spiritualità e del metodo di preghiera di Franz Jálics SJ, che, come vedremo alla fine di questa sezione, lega il proprio metodo di esicasmo alla tradizione di Sant’Ignazio (nota bene: nella sua biografia questo rapporto è davvero ininterrotto!). ↑
- Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, a cura di Giuseppe De Gennaro (Roma: Citta Nuova,2002). ↑
- Cita il gesuita ungherese József Hitter SJ, “Bevezető a Lelkigyakorlatos könyvhöz”, in Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyve, (Budapest: Korda 1940) 5-25. ↑
- Philip Endean SJ, “Spiritual Exercises”, in The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits, ed. Thomas Worcester (Cambridge – New York – Melbourne – Delhy: Cambridge University Press 2017) 757-762. ↑
- La Costituzione della Compagnia di Gesù (in latino: Constitutiones Societatis Iesu) è il testo fondamentale che regola la vita, la missione e l’organizzazione dell’ordine dei gesuiti. Il documento fu redatto da Ignazio stesso tra il 1547 e 1550, dopo che papa Paolo III approvò ufficialmente la Compagnia (con la bolla Regimini militantis Ecclesiae nel 1540). La Costituzione della Compagnia di Gesù indica anche che un regolamento istituzionale non può garantire nulla, ma solo aprire la strada a qualcosa che solo la grazia divina può realizzare. Secondo il punto 414 della Costituzione, ad esempio, gli scolastici (membri dell’Ordine che studiano) devono essere istruiti su come orientarsi in un ambiente a loro estraneo, e poi aggiunge: “E benché questo possa insegnarlo soltanto l’unzione dello Spirito Santo e la prudenza, che Dio nostro Signore comunica a chi confida nella sua divina Maestà” (IV. 8.8) (cfr. Costituzioni della Compagnia di Gesù, UTET, ebook, 414). ↑
- Non c’è da stupirsi che l’idea abbia attirato l’interesse dell’Inquisizione, anche se Sant’Ignazio non fu mai condannato. Si veda a questo proposito il suo sobrio racconto autobiografico: Ignazio di Loyola, Racconto di un pellegrino, a cura di Giuseppe De Gennaro (Roma: Città Nuova, 2004) 81-86. ↑
- Philip Endean SJ, “Spiritual Exercises”, 757-758. ↑
- La vecchia traduzione dell’espressione tres binarios de hombres (Es.148) è “i tre binari”, che in italiano è compresa al massimo solo dagli specialisti. In realtà, il termine risale al vocabolario della filosofia antica e si riferisce alla complessità dell’essere umano composto dal corpo e dall’anima. Il termine “binario” indica quindi questa dualità, ma in realtà si riferisce a una singola persona. ↑
- Per la terza e la quarta Settimana, di solito, troviamo “punti” leggermente diversi; e le meditazioni e contemplazioni sui “misteri della vita di Cristo nostro Signore” (Ess. 261-312), che formano una sorta di appendice agli Esercizi Spirituali, contengono tipicamente tre elementi della scena evangelica. ↑
- Sul metodo tipicamente ignaziano di “applicare i sensi” (aplicar los sentidos), cfr. Ess. 121-126. ↑
- Philip Endean SJ, “Contemplation” 200-201. ↑
- Il metodo di Sant’Ignazio, qui descritto, riceve un’impronta dalla tradizione immaginativa bernardiniana e francescano-pseudo-bonaventuriana (Ioannes Caulibus ecc.), a lui giunta attraverso la Vita Christi di Ludolfo di Cartagine e il Compendio breve de ejercicios espirituales di Montserrat. ↑
- “Il concetto di “difficoltà ad esprimersi attraverso il linguaggio” (Sprachnot) deriva dal filosofo Hans-Georg Gadamer, che usa questo termine per riferirsi alle difficoltà concettuali dell’ermeneutica filosofica (teoria dell’interpretazione), vale a dire la sua insufficienza nell’esprimere linguisticamente la realtà. Come scrive Gadamer: “E mi sembra che questo sia il grande dramma mozzafiato della filosofia, il costante sforzo di trovare il linguaggio, per dirla in modo più patetico: la costante sofferenza per la mancanza di linguaggio”. (Und dies scheint mir nun wirklich das große atemberaubende Drama der Philosophie, dass sie die ständige Bemühung um Sprachfindung, um es pathetischer zu sagen: ein beständiges Erleiden von Sprachnot ist). Hans-Georg Gadamer, “Begriffsgeschichte als Philosophie”, in Idem, Gesammelte Werke 2, Heremeutik II, (Tübingen: Mohr, 1993), 77-91; “Selbstdarstellung Hans-Georg Gadamer”, in Idem, Gesammelte Werke, 479-508. ↑
- Henry Shea SJ, “Composition of Place”, in The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits, ed. Thomas Worcester (Cambridge – New York – Melbourne – Delhy: Cambridge University Press, 2017) 7-20. ↑
- Una fortunata tradizione pedagogica dei gesuiti francesi semplifica l’esecuzione della preghiera a soli quattro punti: 1. “essere presente” (present); 2. “chiedere scusa” (pardon), 3. “ringraziamento” (merci), 4. “guardare avanti” (demain). Questo è di per sé un buon esempio di applicazione degli Esercizi Spirituali. Per una buona sintesi di altri nomi possibili per l’esame di coscienza (“preghiera di attenzione amorosa”, “preghiera di previsione amorosa”, “preghiera di attenzione”, “preghiera di attenzione costante”) Willi Lambert, Aus Liebe zur Wirklichkeit: Grundworte ignatianischer Spiritualität (Kevelaer: Topos Plus, 2008), 71-78. ↑
- George Aschenbrenner, “Consciousness Examen,” Review for Religious 31, (1972): 14-21. ↑
- Timothy Gallagher, The examen Preyer: Ignatian Wisdom for Our Lives Today, (New York: Crossroad, 2006), 290-291. ↑
- Sant’Ignazio racconta nella sua autobiografia la sua esperienza mistica sulle rive del fiume Cardoner. ↑
- Il Direttorio è un testo fondamentale che raccoglie indicazioni pratiche e metodologiche per la guida degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Venne redatto e promulgato nel 1599, sotto il governo del quarto Preposito Generale Claudio Acquaviva, e rimase per secoli un punto di riferimento normativo per i gesuiti. ↑
- Philip Endean SJ, “Contemplation to Attain Love”, in The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits, ed. Thomas Worcester (Cambridge – New York – Melbourne – Delhy: Cambridge University Press 2017), 201-202. ↑
- Ángel Tejerina, “Tres modos de orar”, Man 69, (1997): 51-67. Ángel Tejerina, “Modos de orar” in Dizionario de espiritualidad ignaciana (G-Z), ed. José García de Castro (Madrid: Mensajero – Sal Terrae, 2007), 1278-1282. ↑
- Racconti di un pellegrino russo, a cura di Aleksej Pentkovskij, (Roma: Città Nuova, 1999). ↑
- Ángel Tejerina, “Modos de orar”1282; Santiago Arzubialde SJ, “Tres modos de orar”, in Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Historia y anaálisis, (Bilbao-Santander: Mensajero-Sal Terrae, 2009), 505-533. ↑
- Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, a cura di Giuseppe De Gennaro (Roma: Citta Nuova,2002), 147. ↑
- Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Jean Daniélou, Edward Schillebeeckx ecc. ↑
- Secondo Tibor Bartók SJ, Es. 15 non significa un collegamento “diretto” nel senso Pneumo-centrico ma invece nel senso Logos-centrico (Verbum incarnatum). Per Sant’Ignazio, Cristo appare spesso come “Criador”, “eterno Señor de todas las cosas”, ecc. (Tibor Bartók, “Az ignáci lelkiség forrásai”, https://adoc.pub/szasz-ludolf-vita-christi-2-ludolfo-de-sajonia-la-vida-de-cr.html). ↑
- Questa diversità è già stabilita negli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio. Come abbiamo già visto sopra: “questi esercizi si devono applicare in relazione alla condizione delle persone e cioè secondo l’età, l’istruzione o l’ingegno che hanno” (Es. 18). Philip Endean scrive con notevole sensibilità ermeneutica: “Sebbene il riferimento al Libro degli Esercizi spirituali sia costante nella storia dei gesuiti, l’influenza del testo varia a seconda della diversità delle culture religiose. Il rispetto per la stessa eredità ignaziana non è mai stato disgiunto […] dalla lettura contemporanea (Though reference to Spiritual Exercises is a constant throughout Jesuit history, the text’s effects vary according to the diversity of religious cultures. Veneration for the Ignatian heritage itself has never been separated from […] a contemporary reading)”, Philip Endean SJ “Spiritual Exercises” 758). ↑
- Questa svolta nella cultura della spiritualità ecclesiale è stata chiaramente visibile fin dai primi decenni del XX secolo. Un’eccellente sintesi dell’argomento in ungherese: Görföl Tibor, “A keresztény misztika néhány problémája,” in A kritika hangja és a valóság szeretete, A kereszténység korunk európai kultúrájában, (Budapest: Gondolat, 2018), 133–145. ↑
- In tempi recenti, oltre al gesuita Franz Jálics, per es. Laurence Freeman e Thomas Keating (1923-2018). Quest’ultimo, monaco trappista americano, ha seguito le orme di Thomas Merton (1915-1968) nel riabilitare la “contemplazione” in senso moderno.
Thomas Keating, Divine Therapy and Addiction. Centering Prayer and the Twelve Steps (New York: Lantern Publishing & Media, 2010); Open Mind, Open Heart. The Contemplative Dimension of the Gospel (New York: Continuum, 2002); Intimacy with God. An Introduction to Centering Prayer (New York: Crossroad, 2009); The Human Condition: Contemplation and Transformation (New York: Paulist Press, Mahwah [NJ], 1999). Per l’opera della sua vita ed opera, cfr. Murchadh ó Madagáin, An evaluation and Critical Analysis of the Writing of Thomas Keating on Centering Preyer, Galway, 2005). ↑
- Il titolo del libro di Franz Jálics in italiano è stato leggermente modificato: Desiderio di Dio. Esercizi di contemplazion (Milano: Ancora, 2000). L’originale: Franz Jálics, Kontemplative Exerzitien. Eine Einführung in die kontemplative Lebenshaltung und in das Jesusgebet (Würzburg: Echter, 12. Auflage, 2009). ↑
- Altri libri suoi in italiano: Impariamo a pregare. Una guida al dialogo con Dio (Roma: Edizioni Appunti di Viaggio, 2000); Preghiera silenziosa e accompagnamento spirituale. Radici Evangeliche (Roma: Edizioni Appunti di Viaggio, 2017). ↑